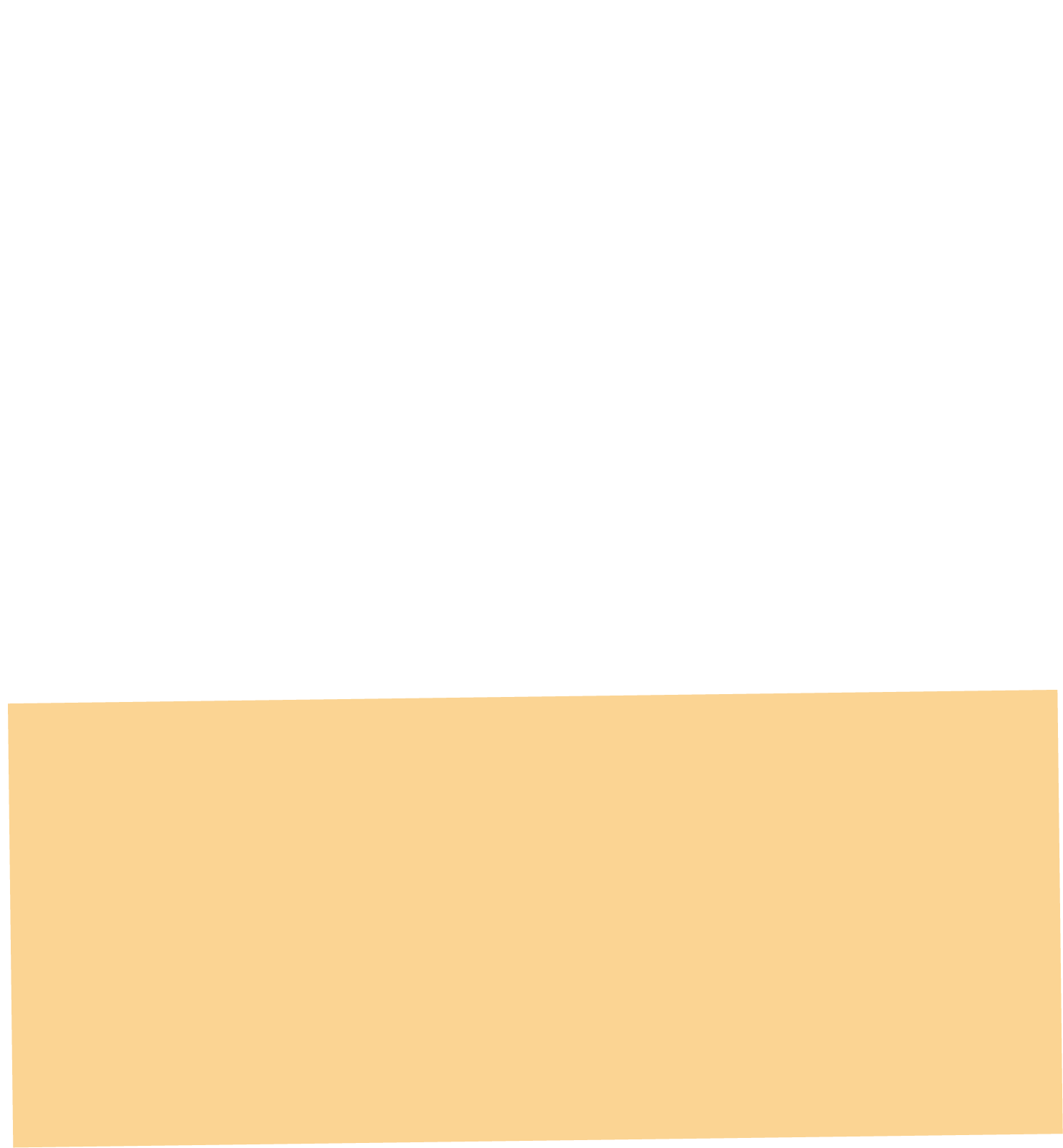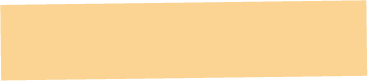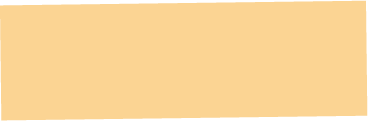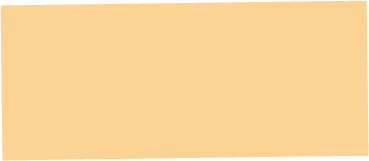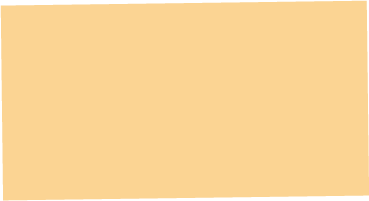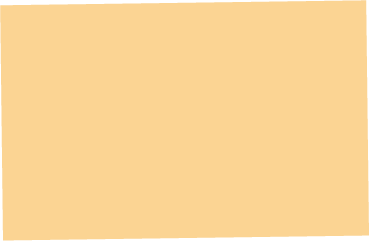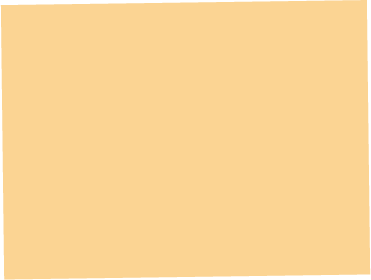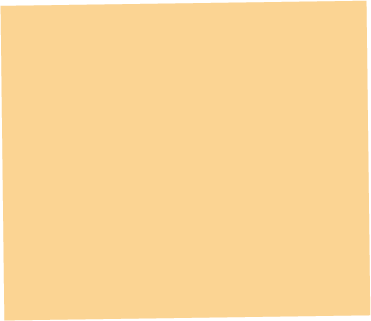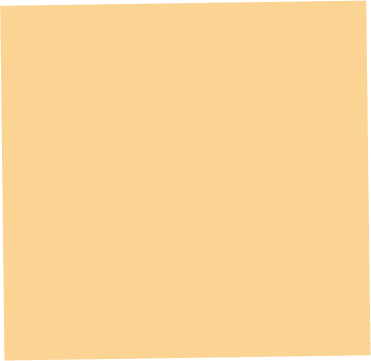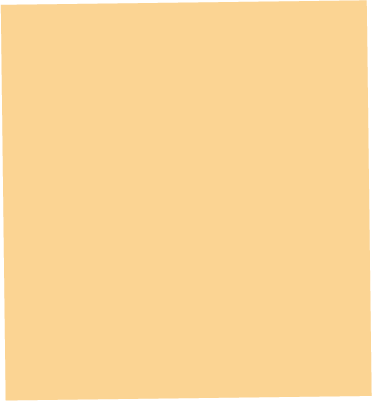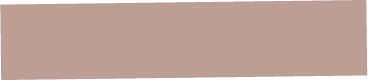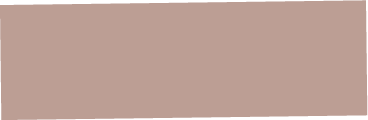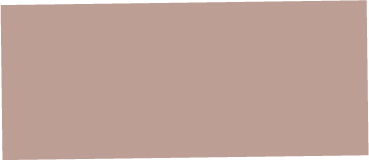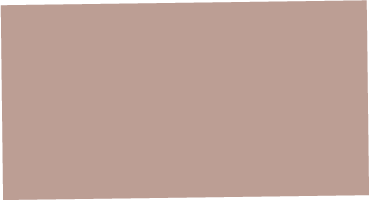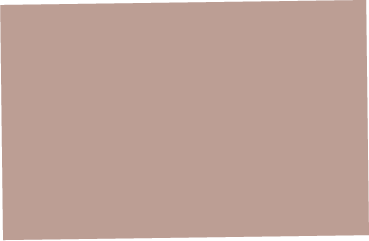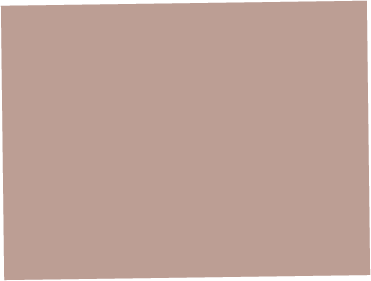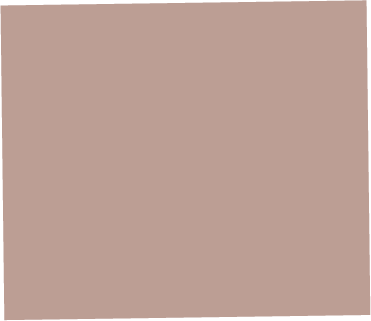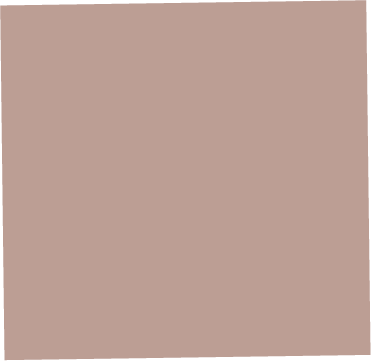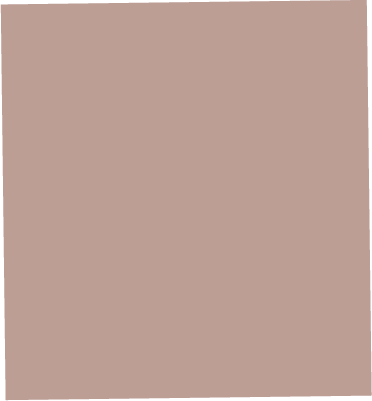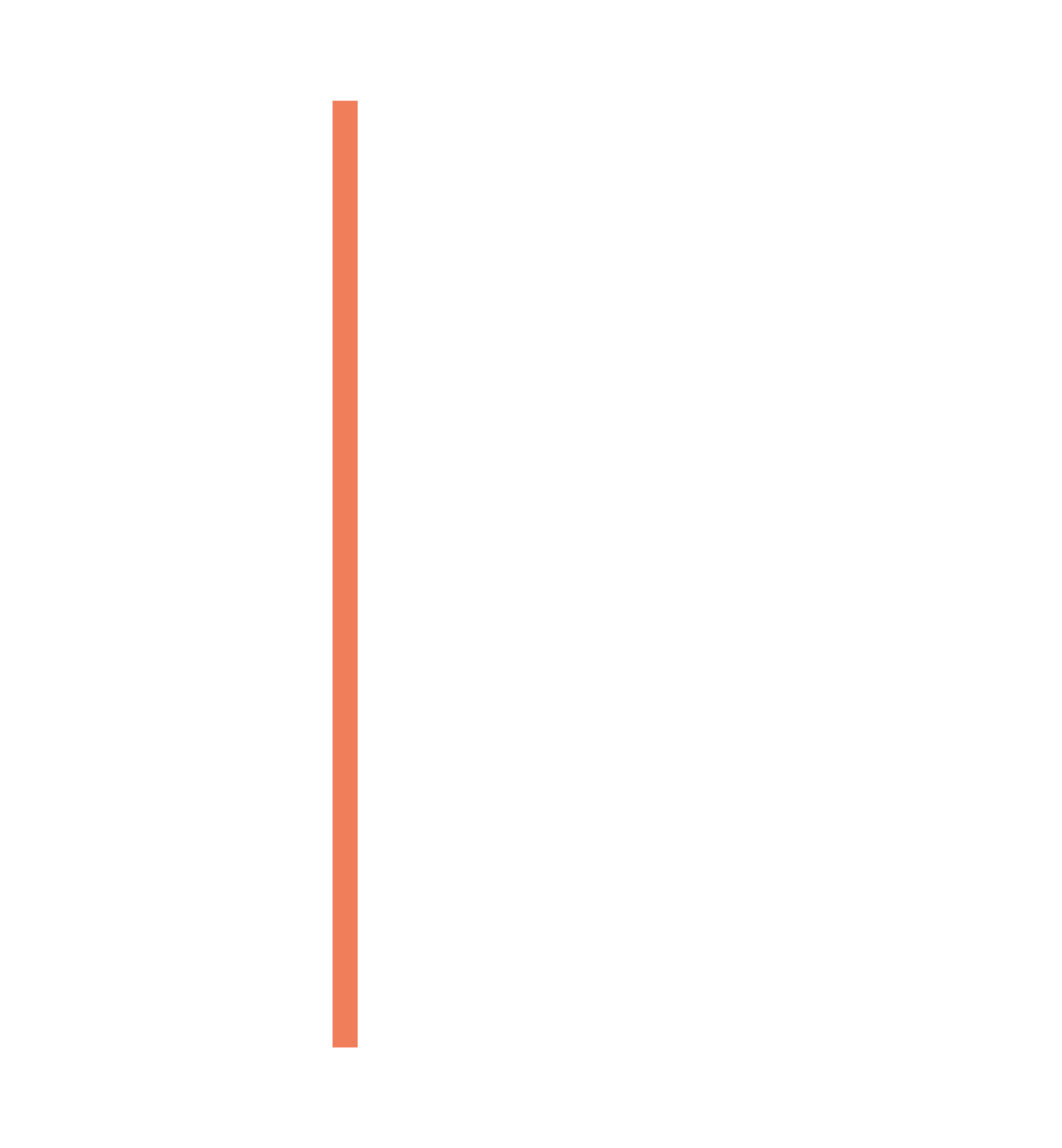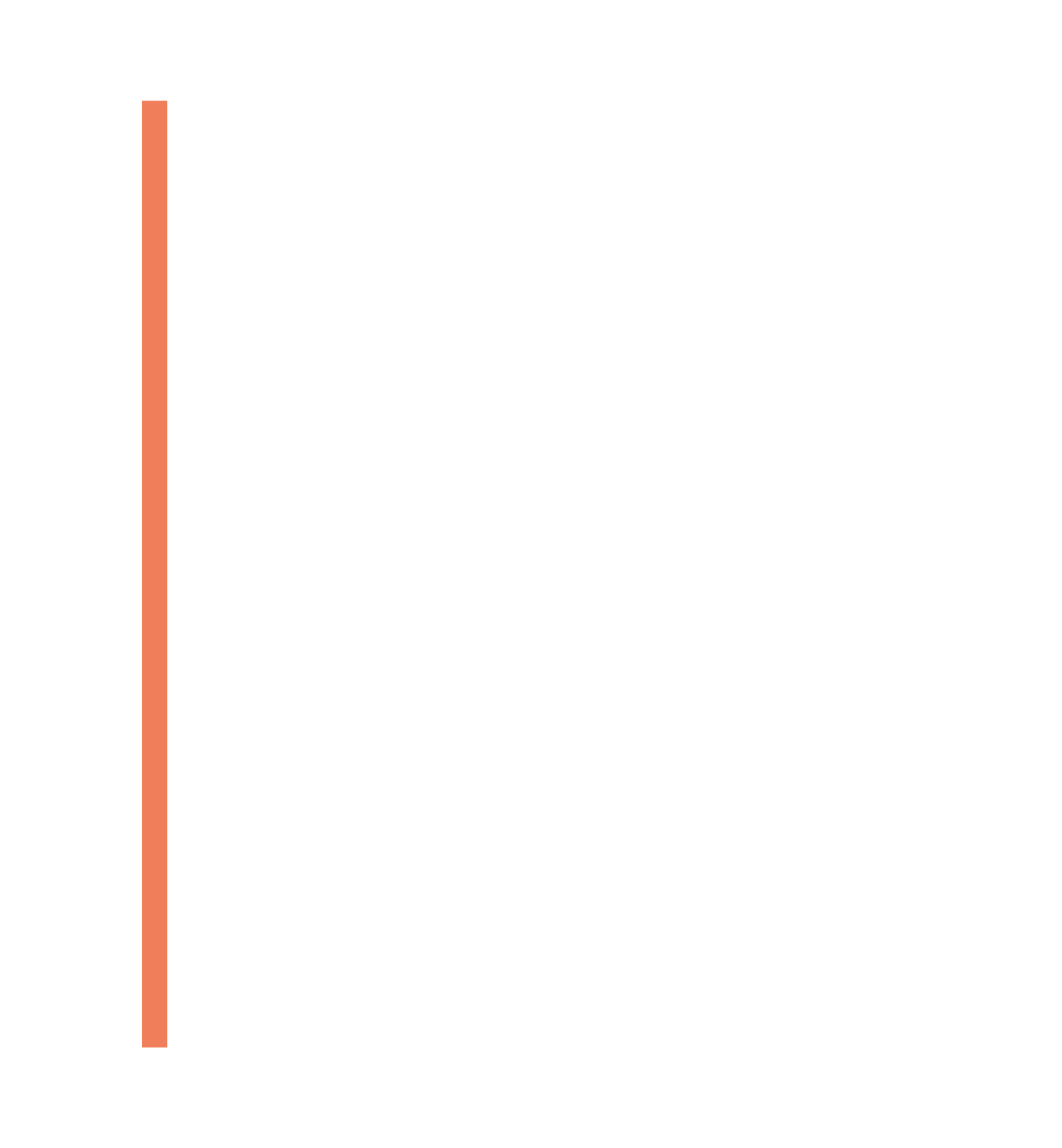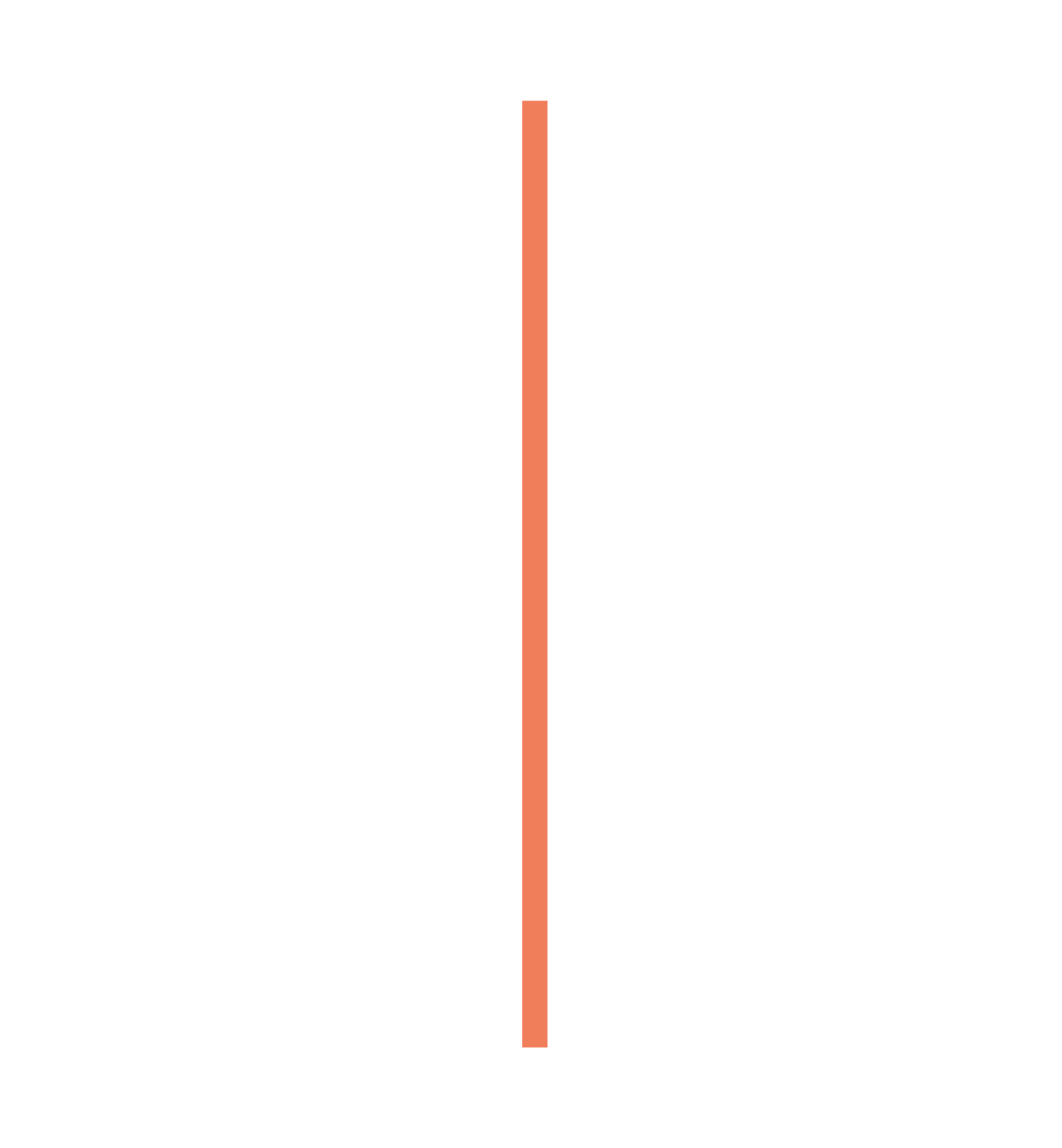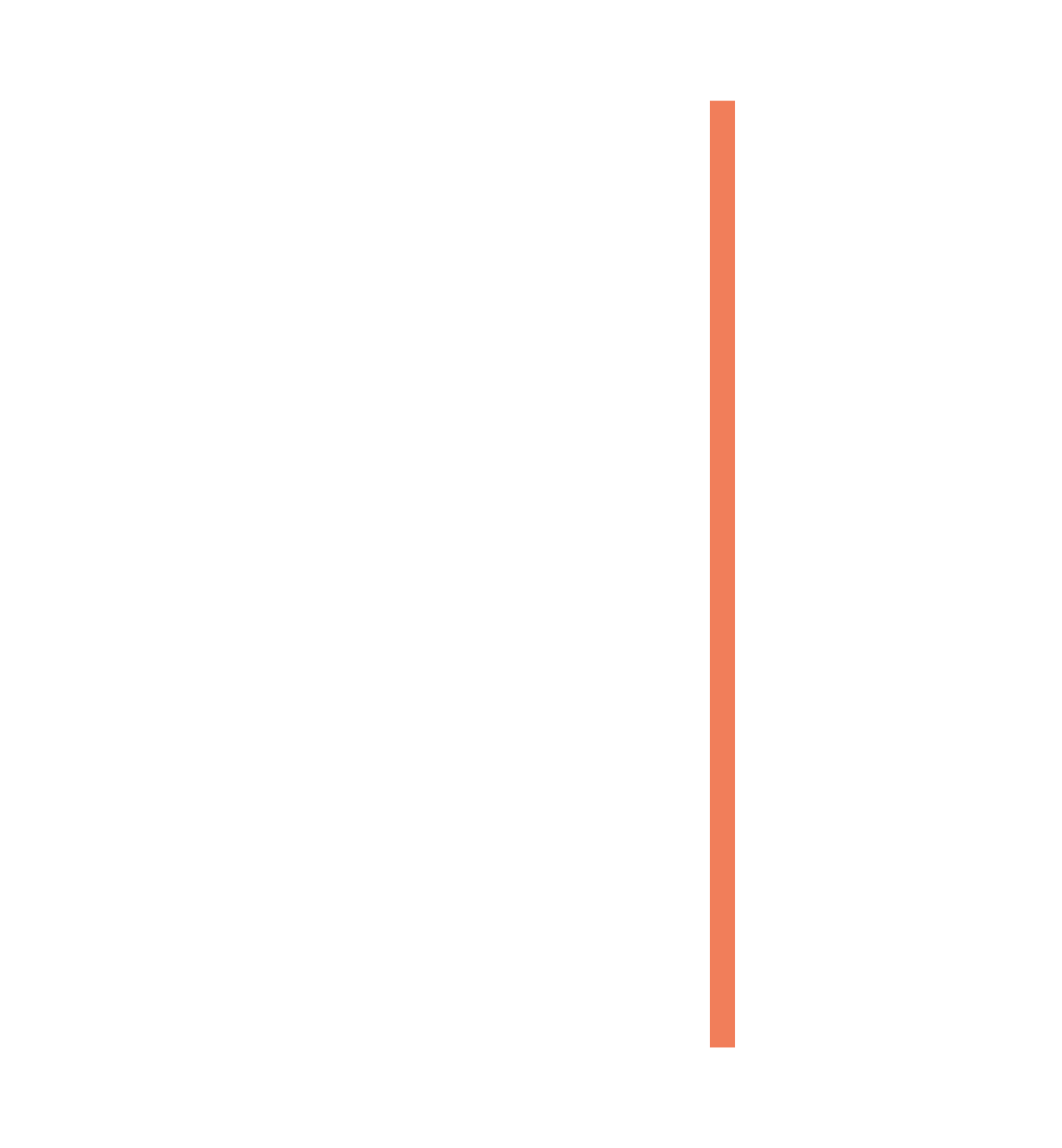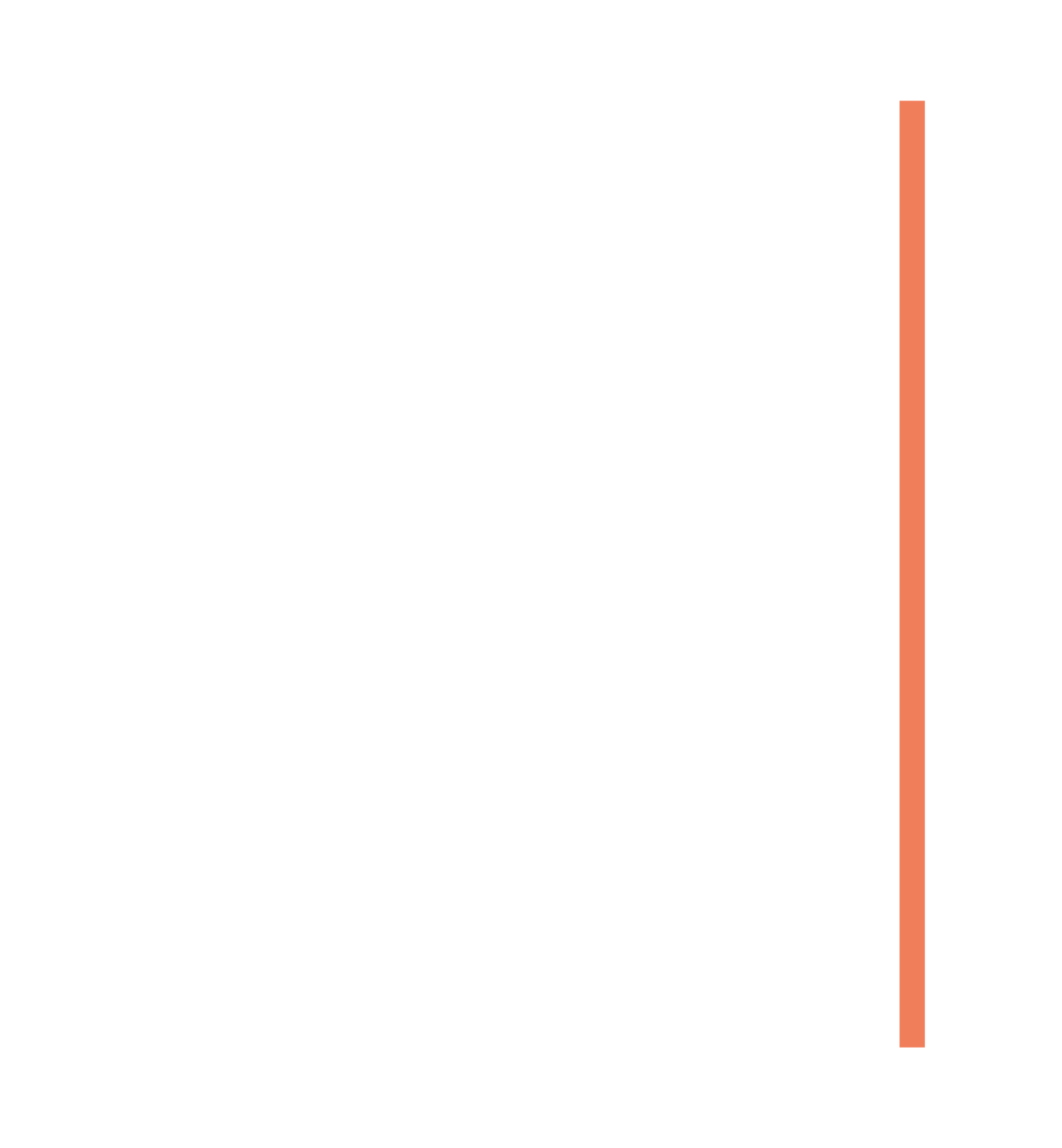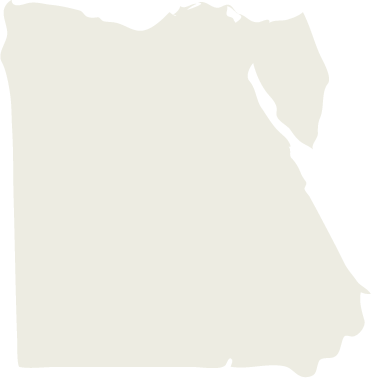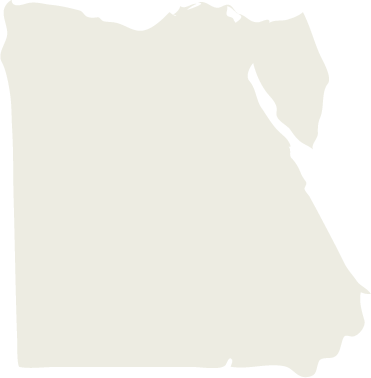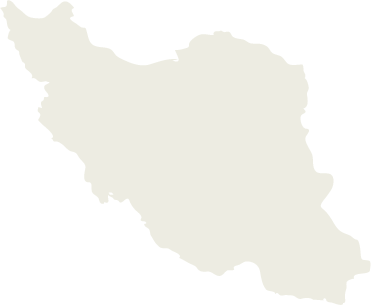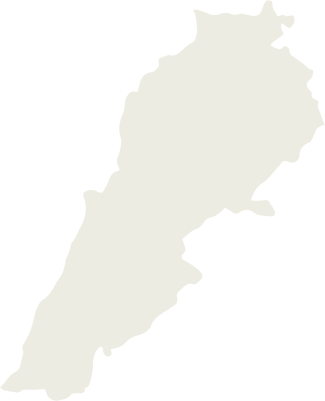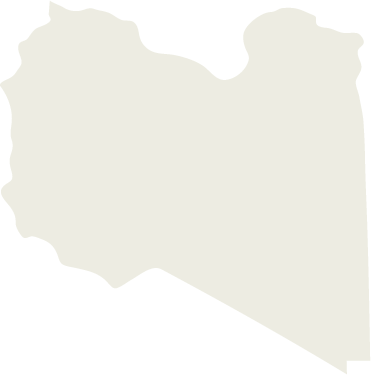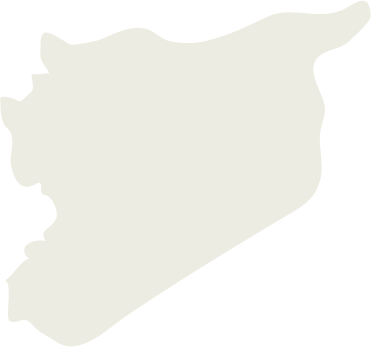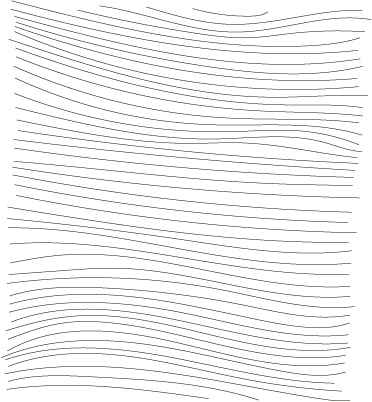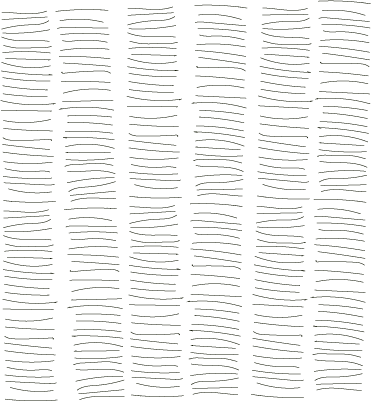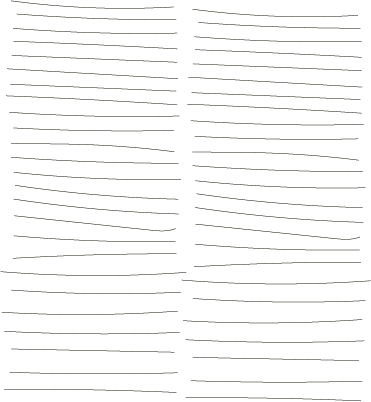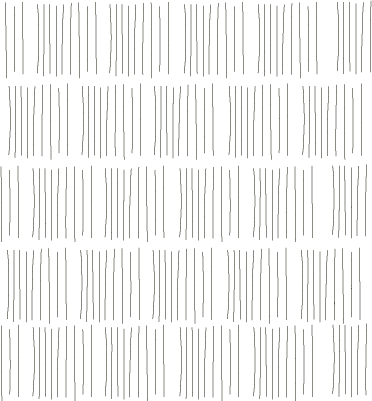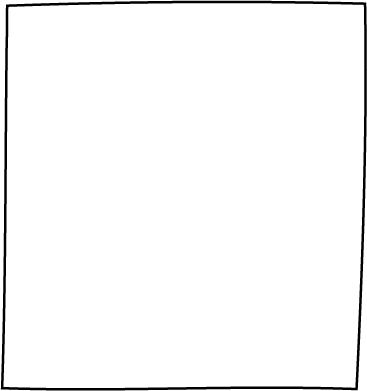Elise Mirna Legziel nasce a Bengasi nel 1939, in una famiglia di origine ebraica profondamente radicata in Libia ma con legami storici che si estendono fino alla comunità ebraica di Livorno e Istanbul. In un contesto segnato dal dominio coloniale, la famiglia abbraccia la cultura italiana pur essendo in possesso di un passaporto francese, acquisito nel corso dell’Ottocento, grazie ai rapporti commerciali intrattenuti dalla famiglia con la Francia.
La prima infanzia di Elise Mirna è segnata dall’instabilità e dall’incertezza. La sua nascita coincide con la Seconda guerra mondiale che sconvolge il Paese. La situazione per le comunità ebraiche peggiora con l’introduzione delle leggi razziali fasciste, che impongono restrizioni e discriminazioni sempre più pesanti. A questo si aggiungono i violenti scontri militari che trasformano Bengasi in un teatro di guerra, con la città contesa tra le forze italiane e britanniche. Questo clima di pericolo e instabilità costringe la famiglia Legziel a lasciare la Libia in cerca di un rifugio sicuro all’estero. Nel 1941, i Legziel seguono l’esercito inglese in ritirata verso l’Egitto, prima in un campo di raccolta ad Alessandria, poi al Cairo, e da lì in Palestina.

Abbiamo vissuto a Tel Aviv, in Rehov Dizengoff, in una bella baracca di legno
Trascrizione
Elise Mirna Legziel
Io sono nata alla fine del 1939, giusto allo scoppio della Seconda guerra mondiale. So che nel ‘41 siamo scappati dalla Libia, perché avanzavano i tedeschi e gli inglesi si ritiravano verso l’Egitto. Quindi siamo andati, diciamo, al seguito degli inglesi. Siamo andati prima in Egitto, al Cairo, siamo stati lì alcuni mesi e poi siamo andati in Palestina per nove mesi. Abbiamo vissuto a Tel Aviv, in Rehov [via] Dizengoff, in una bella baracca di legno. Dopo siamo ritornati in Egitto, dove mio padre si ammalò di tifo e quando poi è guarito siamo ritornati a Bengasi per vedere cosa era successo dei nostri averi, delle nostre case. Abbiamo trovato le case abbastanza saccheggiate, ma comunque gli [edifici] c’erano.
La famiglia Legziel torna a Bengasi nel 1943, dopo la conquista della Libia da parte degli Alleati e l’inizio dell’occupazione britannica. Questo periodo porta con sé importanti cambiamenti per la comunità ebraica locale, sostenuta dall’arrivo dei soldati ebrei palestinesi arruolati nell’esercito britannico. Questi, insieme alle organizzazioni ebraiche internazionali – come il “Joint” – giocano un ruolo cruciale nella ricostruzione delle comunità ebraiche libiche, offrendo assistenza ai più bisognosi e contribuendo alla riorganizzazione della vita sociale e religiosa.
Oltre a fornire aiuti materiali, i soldati avviano programmi educativi, insegnando l’ebraico e promuovendo l’aliyah, l’emigrazione verso la Terra d’Israele, come parte del risveglio sionista. Elise Mirna frequenta per un anno una scuola ebraica istituita dai soldati, ma i suoi genitori decidono di reinserirla nella scuola italiana, prevedendo una possibile emigrazione futura in Italia.

La maggior parte degli ebrei di Bengasi sono venuti via nel ‘48
Trascrizione
Elise Mirna Legziel
[Mio padre] ci ha raccontato di come è stata organizzata l’aliyah, perché la maggior parte degli ebrei di Bengasi sono venuti via nel ‘48, cioè dopo la fondazione dello Stato di Israele, con l’aiuto del Joint. A proposito del Joint, io mi ricordo che dopo la guerra, quando siamo tornati a Bengasi che c’era poco da mangiare, arrivavano dei pacchi dal Joint di vestiario, sia con del cibo: il famoso formaggio gouda olandese e l’olio di fegato di merluzzo, che tutti noi bambini eravamo obbligati a bere. Però ha salvato tante situazioni quell’orribile fegato di merluzzo. Devo dire che il Joint ci ha aiutato molto, [anche] la Sochnut [l’Agenzia Ebraica]. Dunque i soldati della Brigata Ebraica erano venuti in Libia per vedere di organizzare l’aliyah in massa degli ebrei di Bengasi, a Tripoli non so come era la cosa. Veramente hanno cercato di fare al più presto possibile perché si rendevano conto che più gli ebrei stavano lì, più pericoli correvano. Praticamente son venuti via quasi tutti gli ebrei da Bengasi, saranno rimaste due o tre famiglie, non di più.
In Libia, le comunità ebraiche subiscono due terribili pogrom: il primo nel 1945 e il secondo nel 1948. Questi eventi segnano profondamente la vita della comunità e convincono molte famiglie, tra cui i Legziel, a lasciare il Paese. Nel 1949, la famiglia si trasferisce in Italia, stabilendosi a Milano. Qui, Elise Mirna si iscrive alla scuola ebraica di via Eupili, dove trova un ambiente accogliente. Grazie all’attenzione delle insegnanti e al supporto dei compagni, riesce a integrarsi rapidamente, anche partecipando alle attività delle associazioni scoutistiche ebraiche, che diventano un punto di riferimento importante per lei.