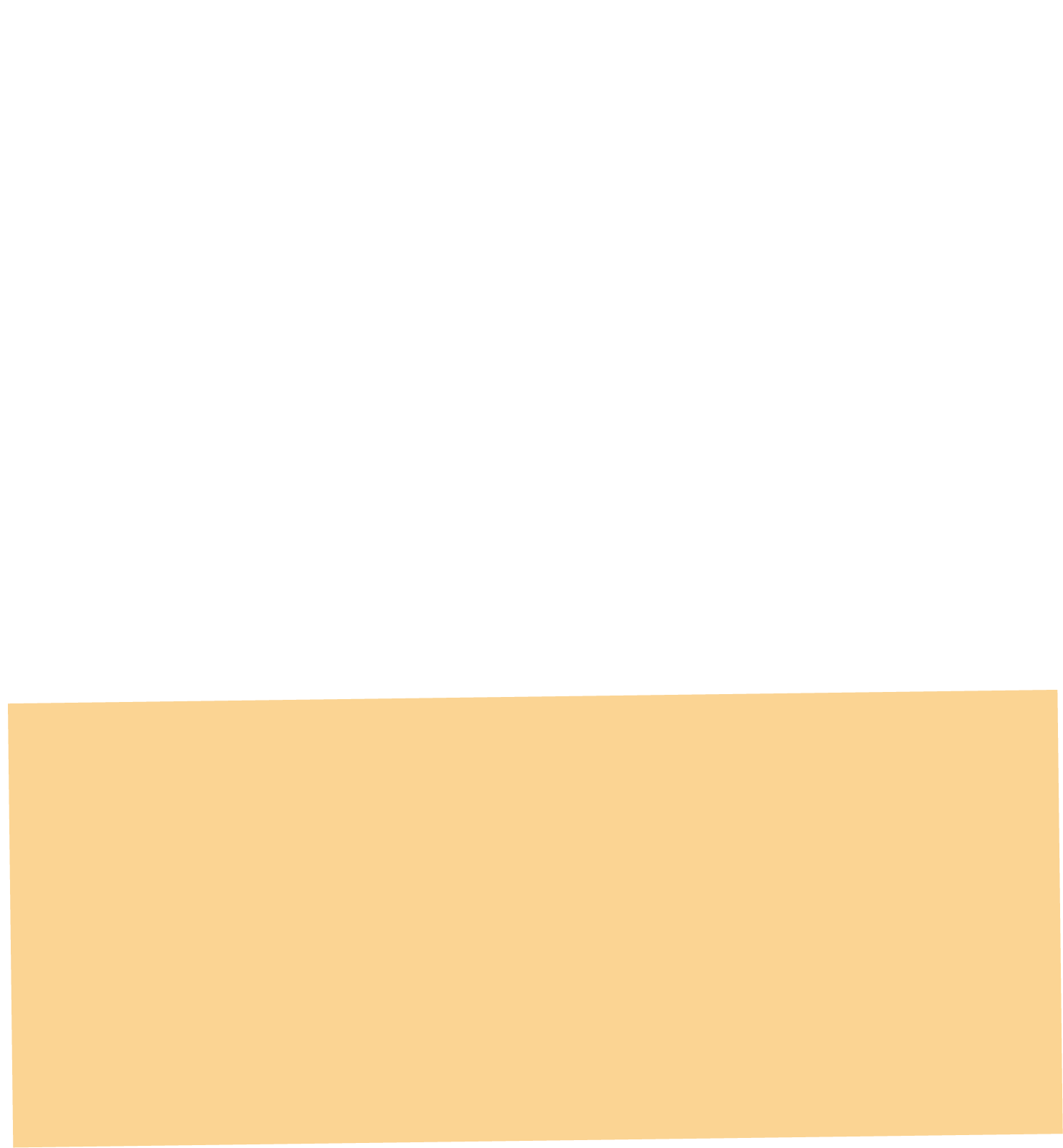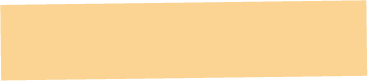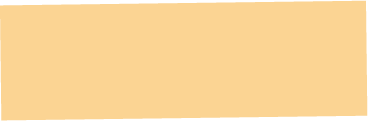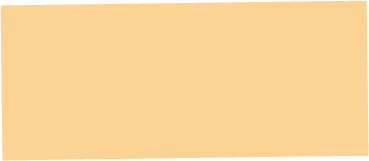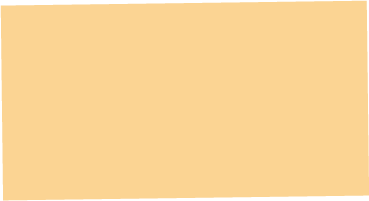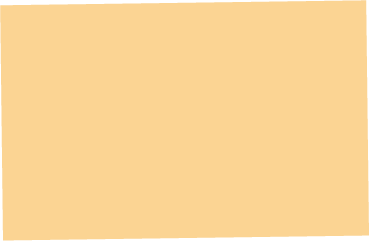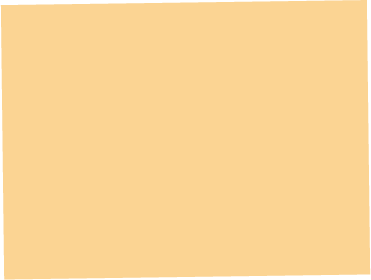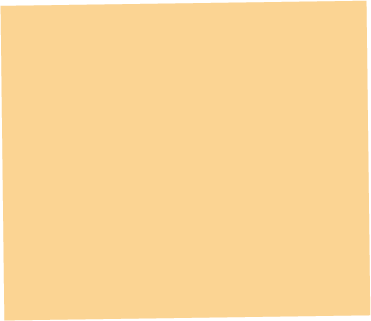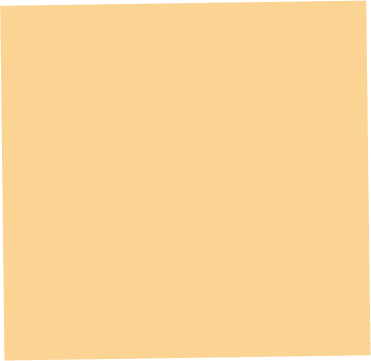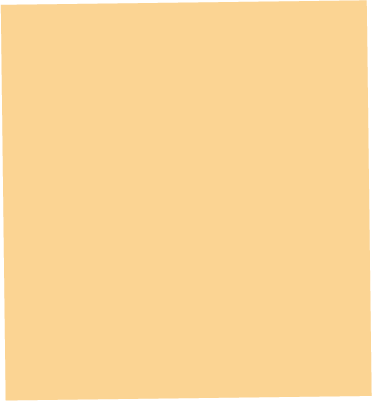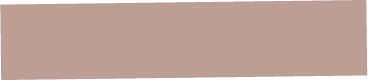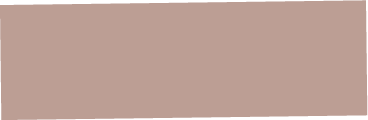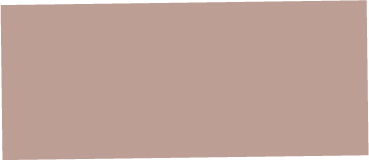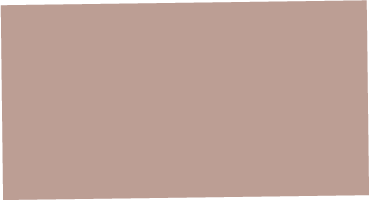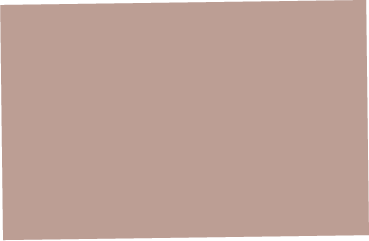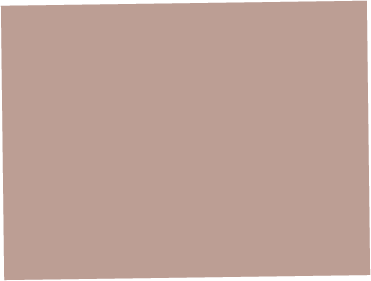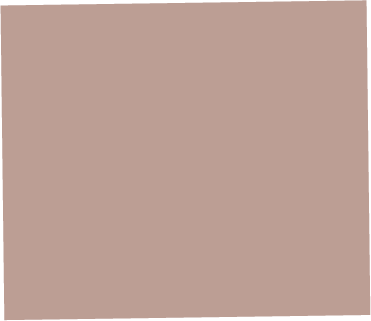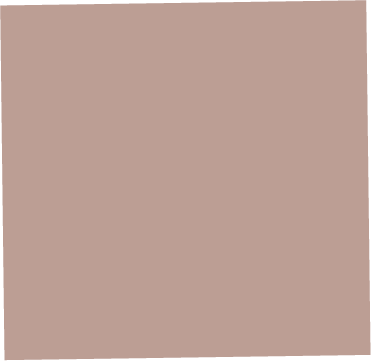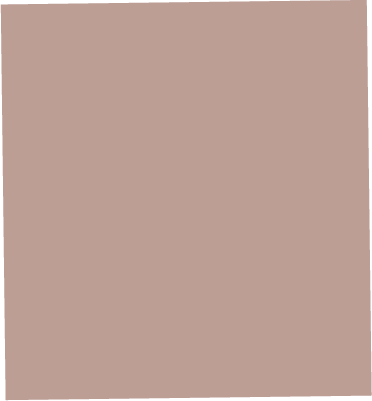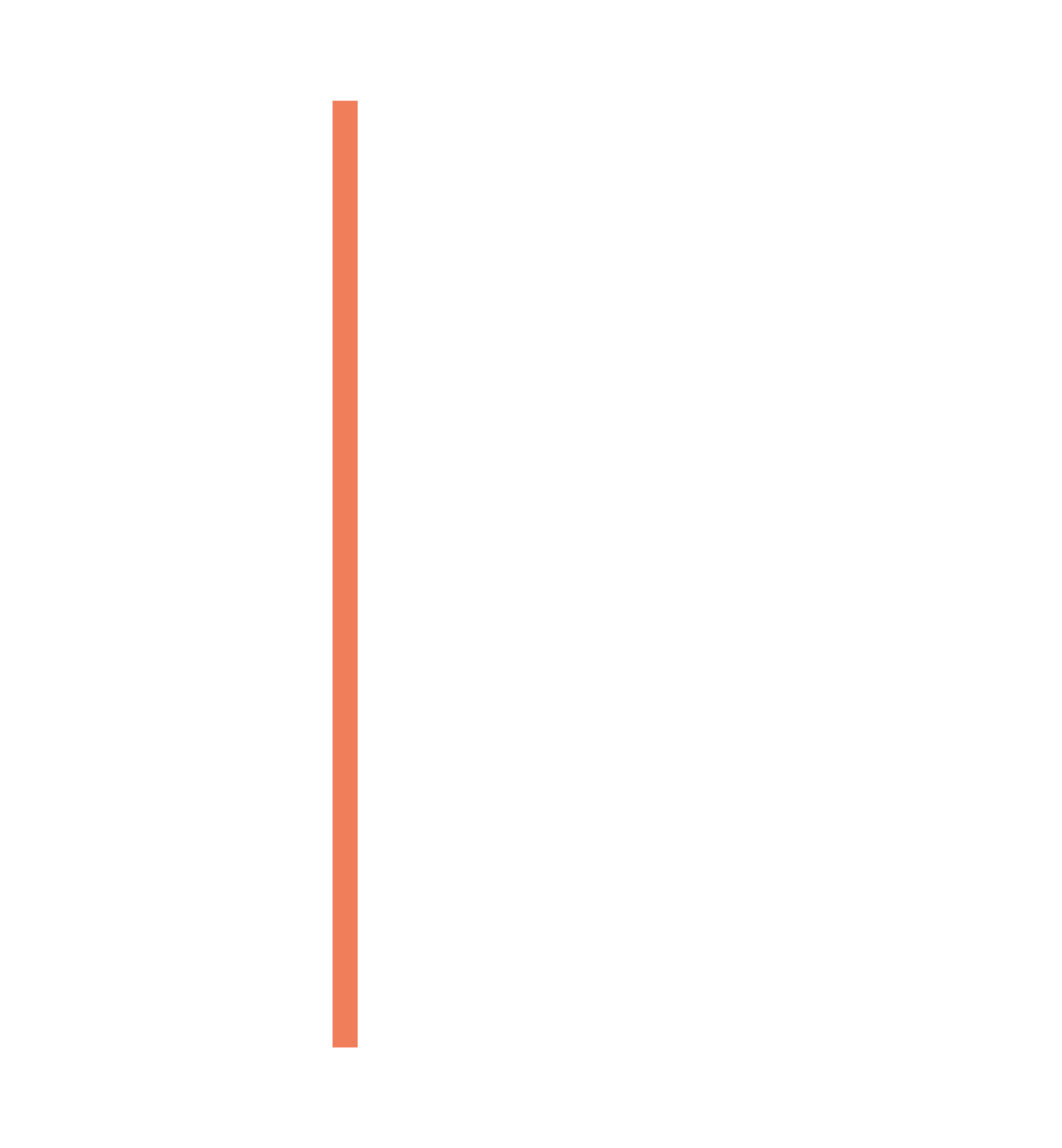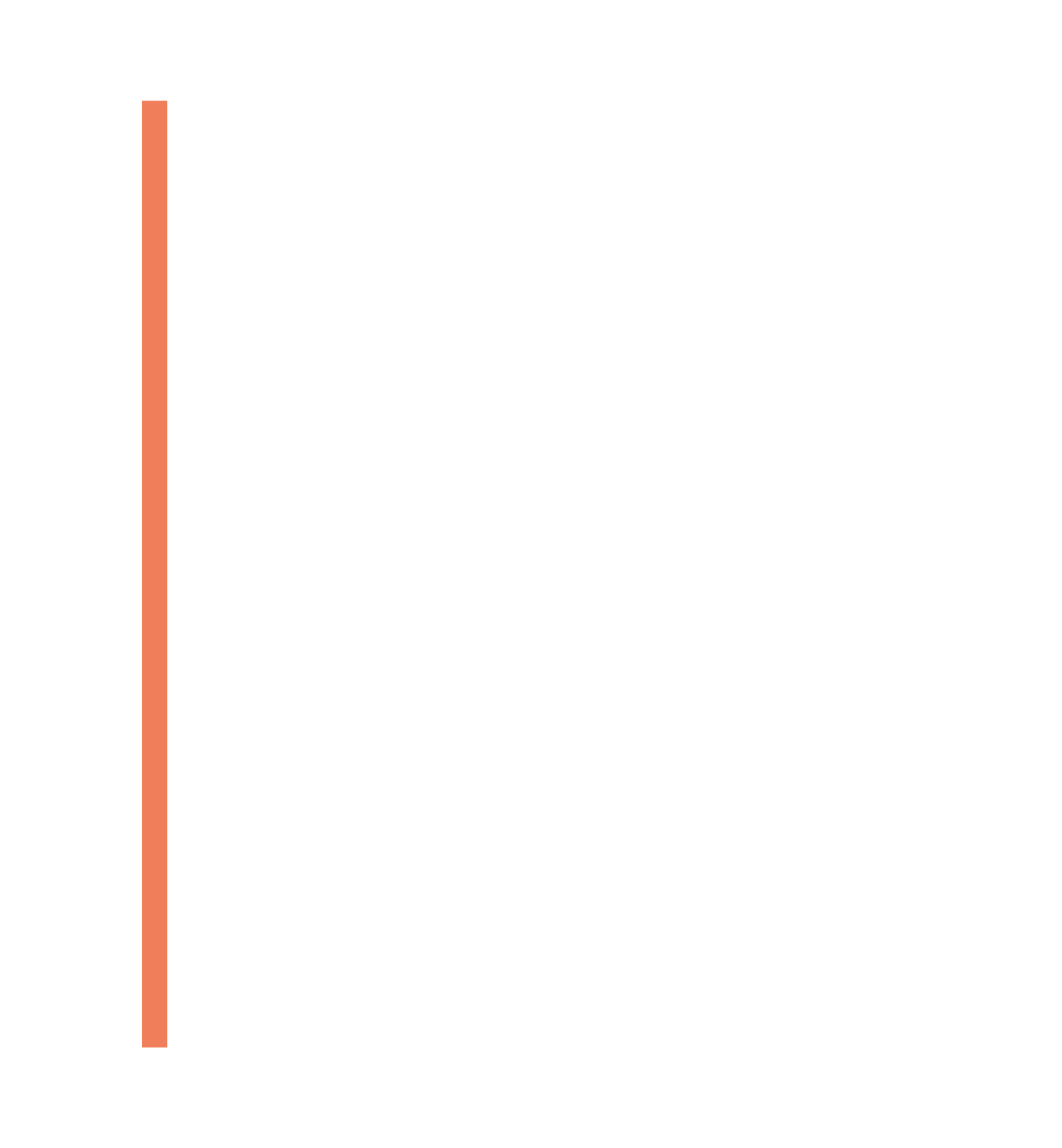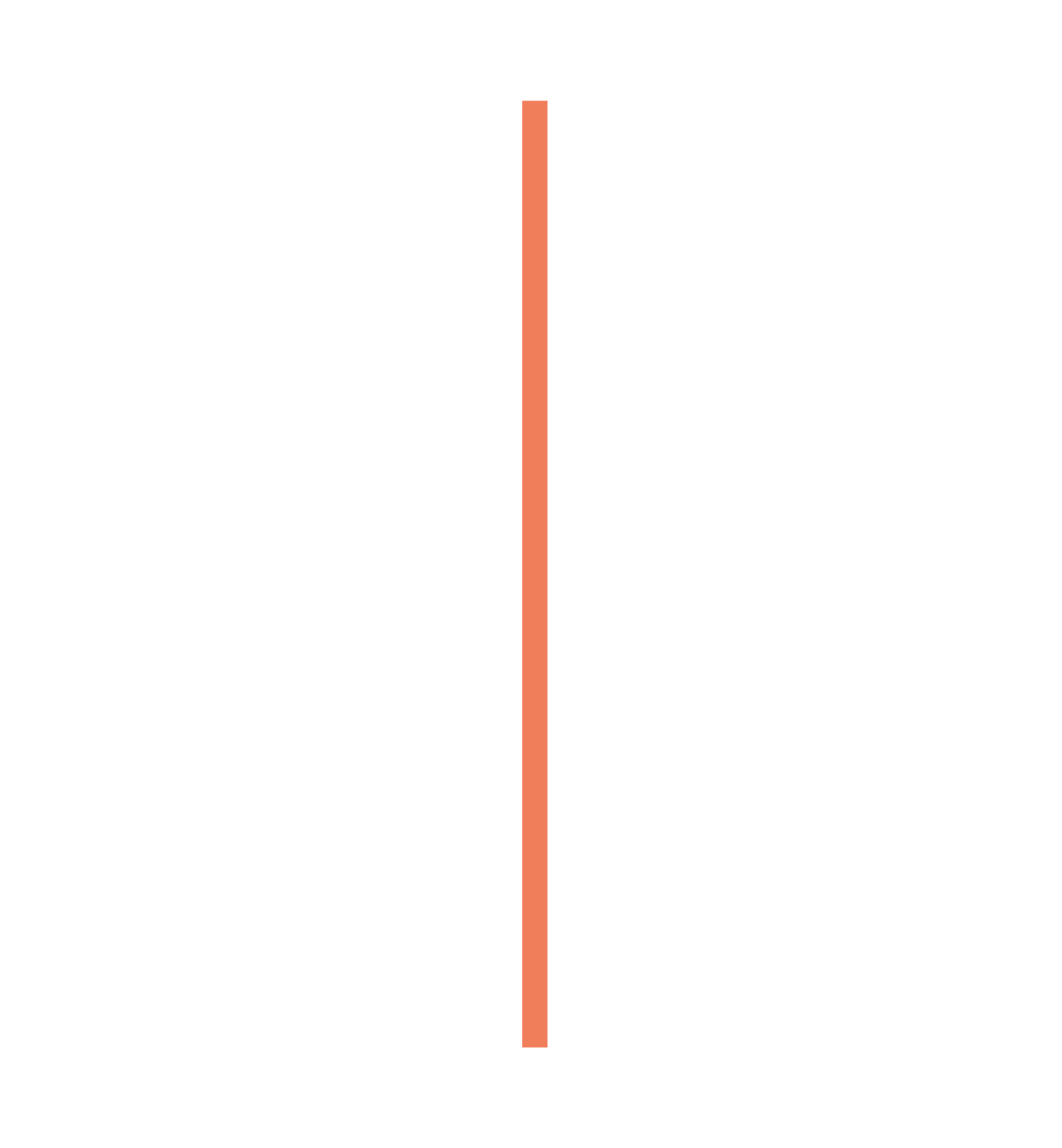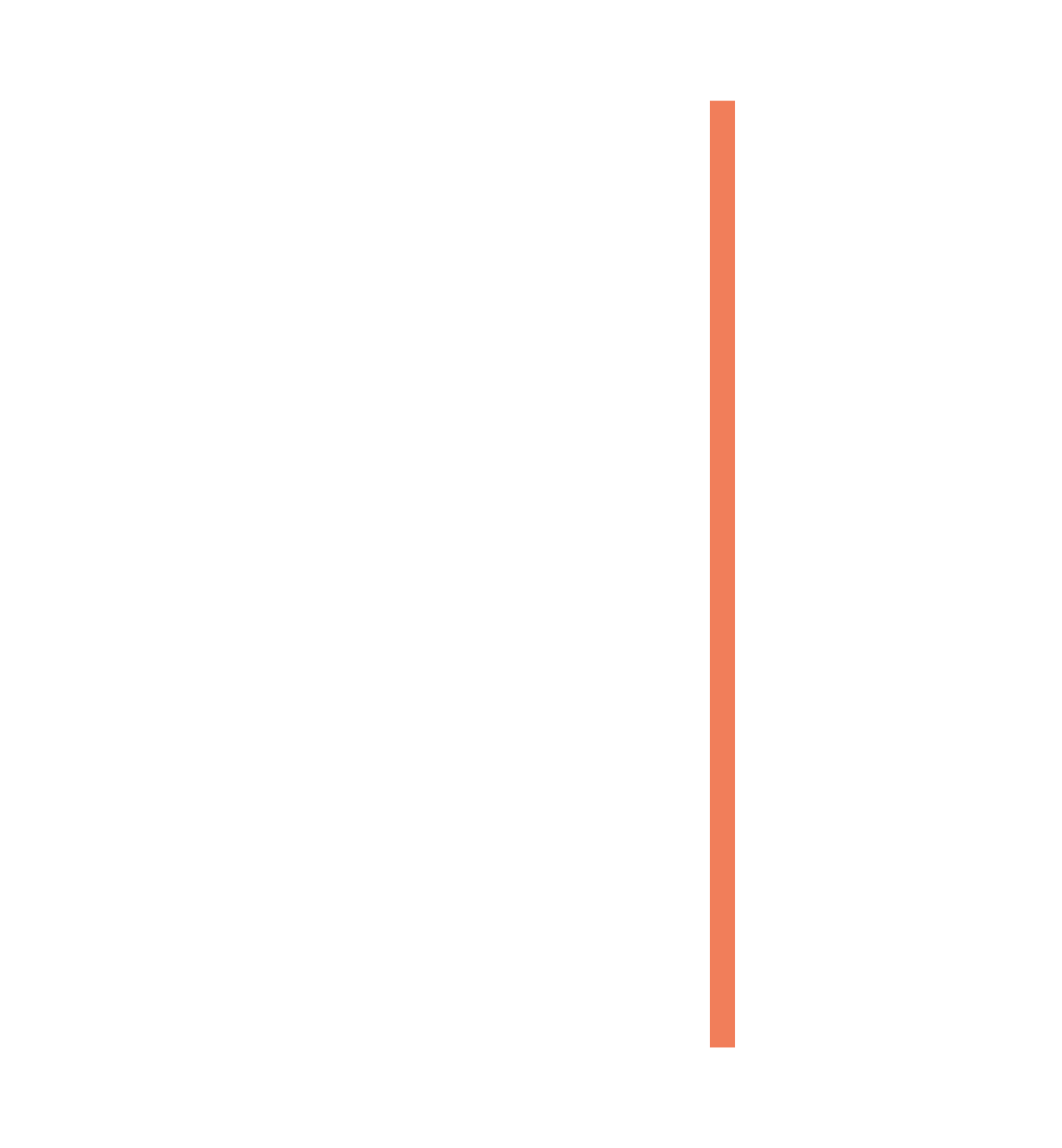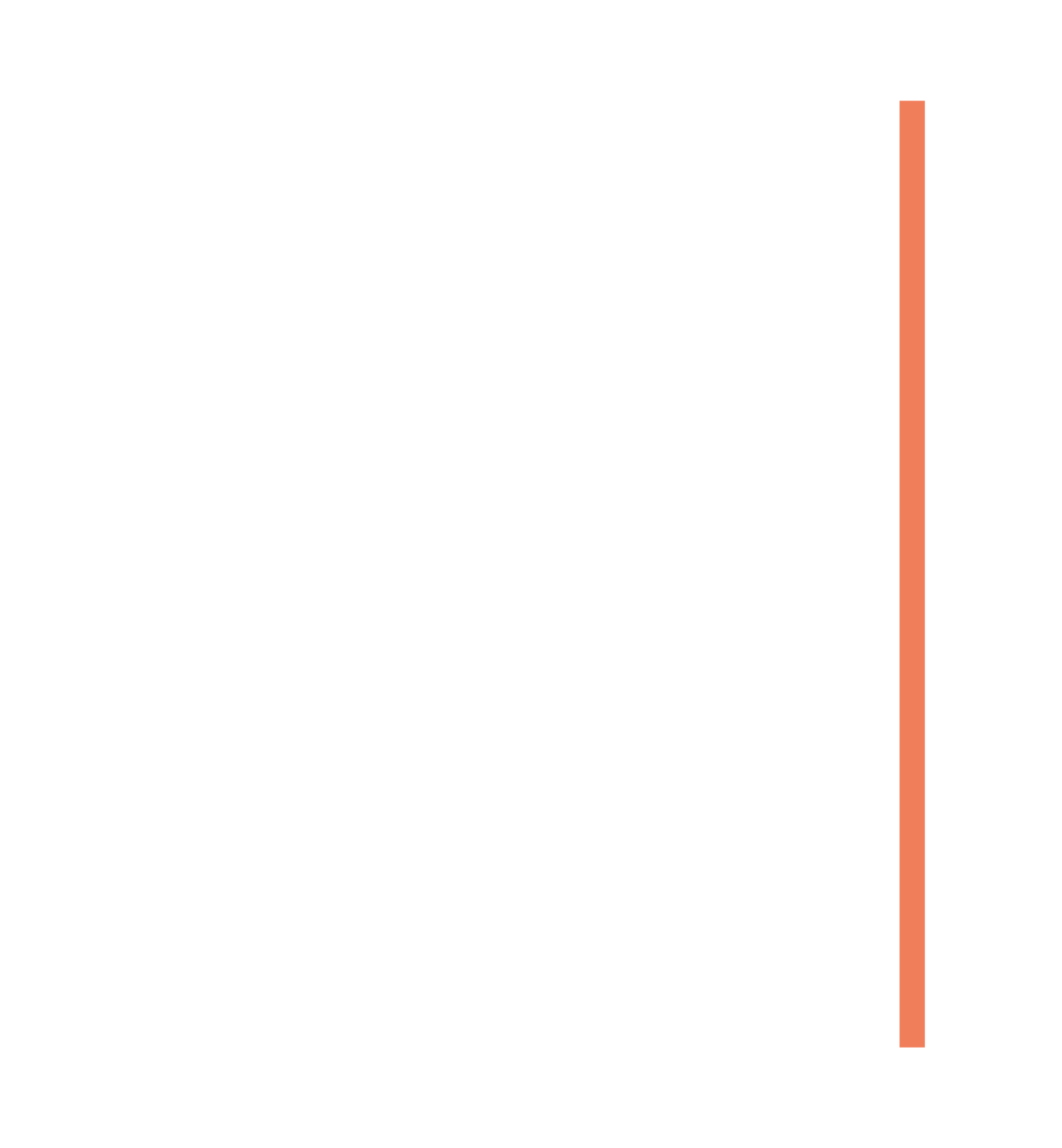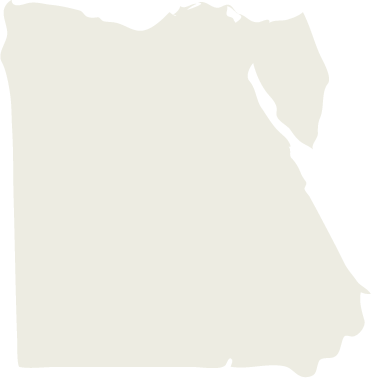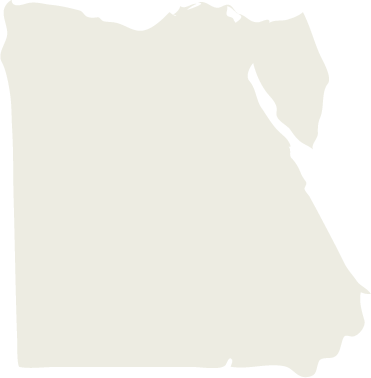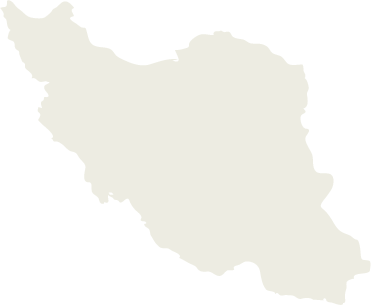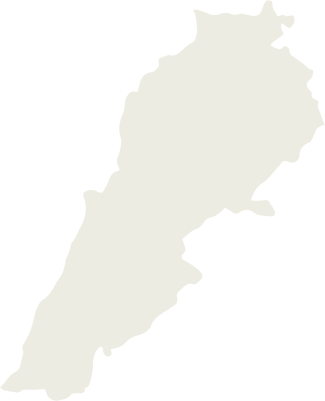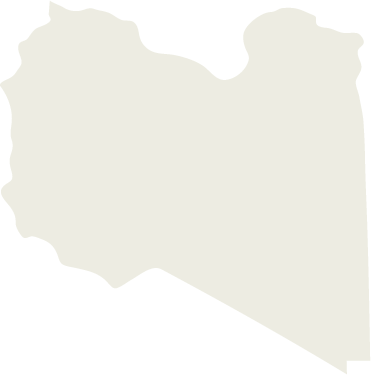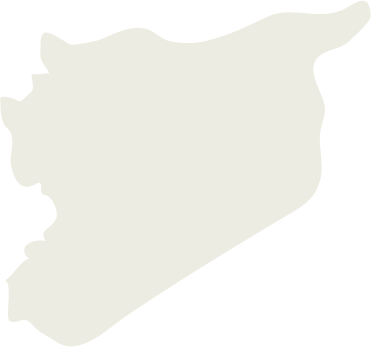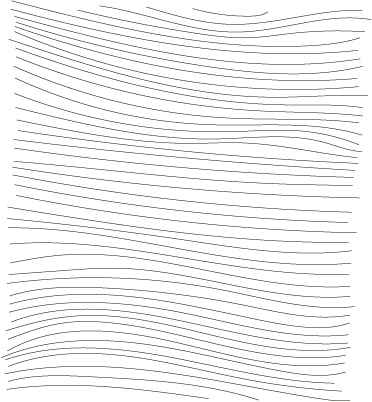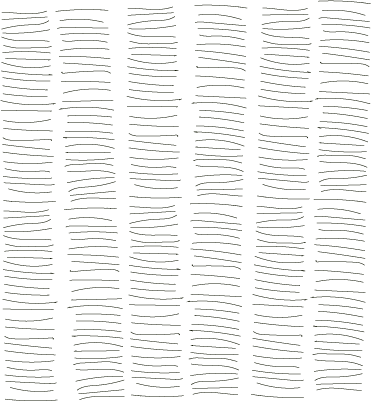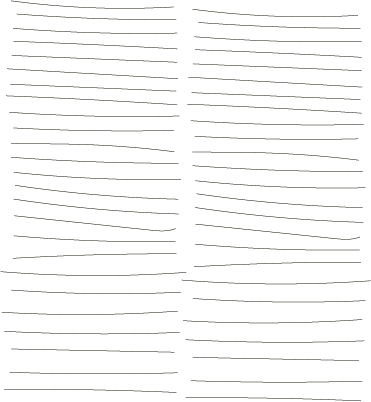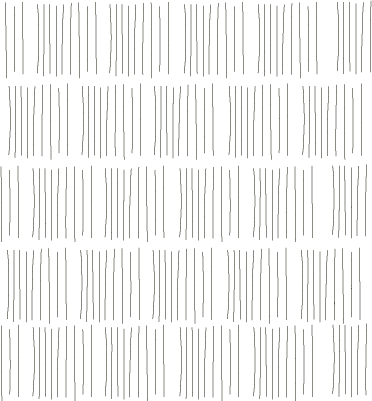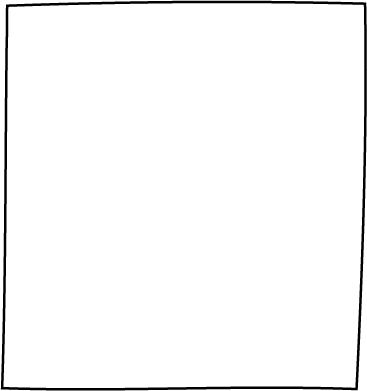Micky Sciama nasce al Cairo, in Egitto, nel 1941 da Marcelle e Edmond Chamma. Entrambi i genitori sono nati in Egitto, ma solo la nonna materna è originaria del Paese; gli altri nonni provengono dalla Siria, da dove emigrarono probabilmente alla fine del XIX secolo, in concomitanza con l’apertura del Canale di Suez. Da almeno tre generazioni la famiglia possiede il passaporto italiano, sebbene non sia chiaro se per discendenza livornese o grazie al regime delle capitolazioni.
La famiglia materna è numerosa: la madre di Micky ha sei sorelle, e lui cresce circondato da zii e cugini in un ambiente caloroso e protettivo. Con i suoi genitori, la sorella Eliane e il fratello Moussy, abita al secondo piano di un edificio nei pressi del Palazzo Abdin, la residenza reale, nel quartiere centrale di Bab El-Louk, a pochi passi da Rue Soliman Pasha. Il quartiere ospita le principali scuole francesi e inglesi del Cairo, frequentate dalla maggior parte degli ebrei della città. Come molti altri coetanei, Micky segue un percorso di studi francese, dalla scuola materna fino al liceo.

Spesso i nostri genitori ci mandavano nelle scuole confessionali cristiane
Trascrizione
Micky Sciama:
Eravamo tutti dalla parte, diciamo, dalla parte sud del Nilo. Ecco, dove abitavo c’erano due scuole molto importanti, c’era il Lycée Français du Caire e c’era l’Ecole des Frères. Il quartiere comunque si chiamava Bab El Luk. Queste due scuole furono frequentate sia dalla mia famiglia, [e da] me personalmente: sono stato a Lycée dalle materne fino al liceo. Il Lycée era frequentato per il 90% da ebrei e stranamente anche all’Ecole des Frères, che era una scuola chiaramente cristiana, ci andavano molti dei nostri correligionari. E questa è una cosa che non ho mai capito: spesso i nostri genitori ci mandavano nelle scuole confessionali cristiane, si andava dai frères [frati], si andava dalle sœurs [suore], si andava anche in altre scuole inglesi, c’era l’English Mission ad esempio, dove molti andavano. Mia moglie è andata a scuola dalle suore irlandesi, addirittura, molto cattoliche. Alla scuola ebraica non si andava.
Intervistatrice:
Perché?
Micky Sciama:
Perchè probabilmente i nostri genitori erano comunque di cultura francese o di cultura inglese ma soprattutto francese, la tendenza era quella di portare i figli in una scuola francese.
Sebbene frequenti spesso il tempio con il padre, la pratica religiosa non si traduce in una conoscenza approfondita dell’ebraismo né in una rigorosa osservanza, anche se il senso di appartenenza resta forte. I rapporti con “les indigènes”, ovvero la popolazione araba, sono cordiali ma limitati al buon vicinato e all’interazione con i domestici. La vita sociale della famiglia è animata dai circoli cittadini, luoghi di aggregazione intergenerazionali dedicati a sport e svago. La sua infanzia e giovinezza in Egitto sono scandite anche dalle gite a Heliopolis, dove si gustava la fetira — una focaccia dolce con panna fresca — e dalle vacanze estive a Ras el-Bar, sull’estuario del Nilo, o ad Alessandria.

Tutti gli ebrei d'Egitto appartenevano a un club
Trascrizione
Micky Sciama:
La vita si trascorreva anche nei club. Tutti gli ebrei d’Egitto appartenevano a un club. Erano essenzialmente tre. C’era c’era il famoso TTC, che era il Teufikiyah Tennis Club, che si trovava in un quartiere che si chiamava En-baba. C’era il Gezira Sporting Club, che si trovava nella Gezira, che è l’isola del Cairo, ed era per le famiglie più agiate, perché chi andava al Gezira Club stava sicuramente meglio di chi andava al TTC. E c’è chi andava anche all’Heliopolis Club, dove c’erano anche i cavalli. La vita al TTC era una vita molto intensa, una vita molto sportiva. Si giocava a ping pong, si giocava a tennis, a palette, erano molto sportivi al club, e chiaramente i genitori potevano anche giocare a carte.
Intervistatrice:
Anche le ragazze venivano?
Micky Sciama:
Al club? Sicuramente. Avremmo delle campionesse di nuoto? Assolutamente sì.
“La mia vita in Egitto è stata un sogno” racconta Micky. Ma quel sogno comincia a incrinarsi nel 1948, in seguito alla fondazione dello Stato di Israele: è proprio in quegli anni che ricorda il manifestarsi di un clima avverso agli ebrei, un fenomeno che in poco tempo si intensifica. L’incendio del Cairo del 1952 e il colpo di Stato che depone re Faruq segnano un’escalation. Con l’ascesa di Nasser e, soprattutto, dopo la guerra di Suez del 1956, la propaganda anti-israeliana si rafforza, cresce l’ostilità verso gli ebrei e iniziano le espulsioni di cittadini francesi e inglesi. È in questo clima che la famiglia comincia a pensare di lasciare il Paese.
Il padre inizialmente pensa al Brasile, ma il progetto viene presto abbandonato. La prima a partire è la sorella Eliane, accolta a Milano dalla zia materna Oro, già emigrata in Italia. Nel 1959 è Micky a lasciare l’Egitto per raggiungere Eliane, che nel frattempo si era trasferita a Bradford, in Inghilterra, dopo il matrimonio con Edwin Fishman. Poco dopo anche il fratello minore Moussy si sposta in Inghilterra, e insieme i due fratelli si trasferiscono a Londra per proseguire gli studi. I genitori emigrano infine a Milano nel 1962.
Dopo la laurea in ingegneria, nel 1966 Micky raggiunge la famiglia a Milano. Qui conosce Viviene, che diventerà sua moglie, e con la quale avrà due figlie, Stefania e Dalia. A Milano Micky riscopre la sua identità ebraica, soprattutto quando le figlie cominciano a frequentare la scuola ebraica. Si avvicina così alla vita comunitaria, ricoprendo per tredici anni il ruolo di segretario della Comunità ebraica.

L'Italia mi ha trasformato, sicuramente, sotto profilo religioso
Trascrizione
Micky Sciama:
Beh, sicuramente un bel paese, sono contento di aver scelto l’Italia come paese di residenza, L’Italia mi ha trasformato, sicuramente, sotto profilo religioso, questo grazie alla scuola ebraica. Devo dire che fin quando mia figlia Stefania non ha studiato la scuola ebraica, la mia vita era una vita molto laica, tutti i miei amici erano colleghi d’ufficio, non frequentavo ebrei, non ero iscritto alla comunità di Milano, non mangiavo casher, ero veramente lontanissimo dell’ebraismo.