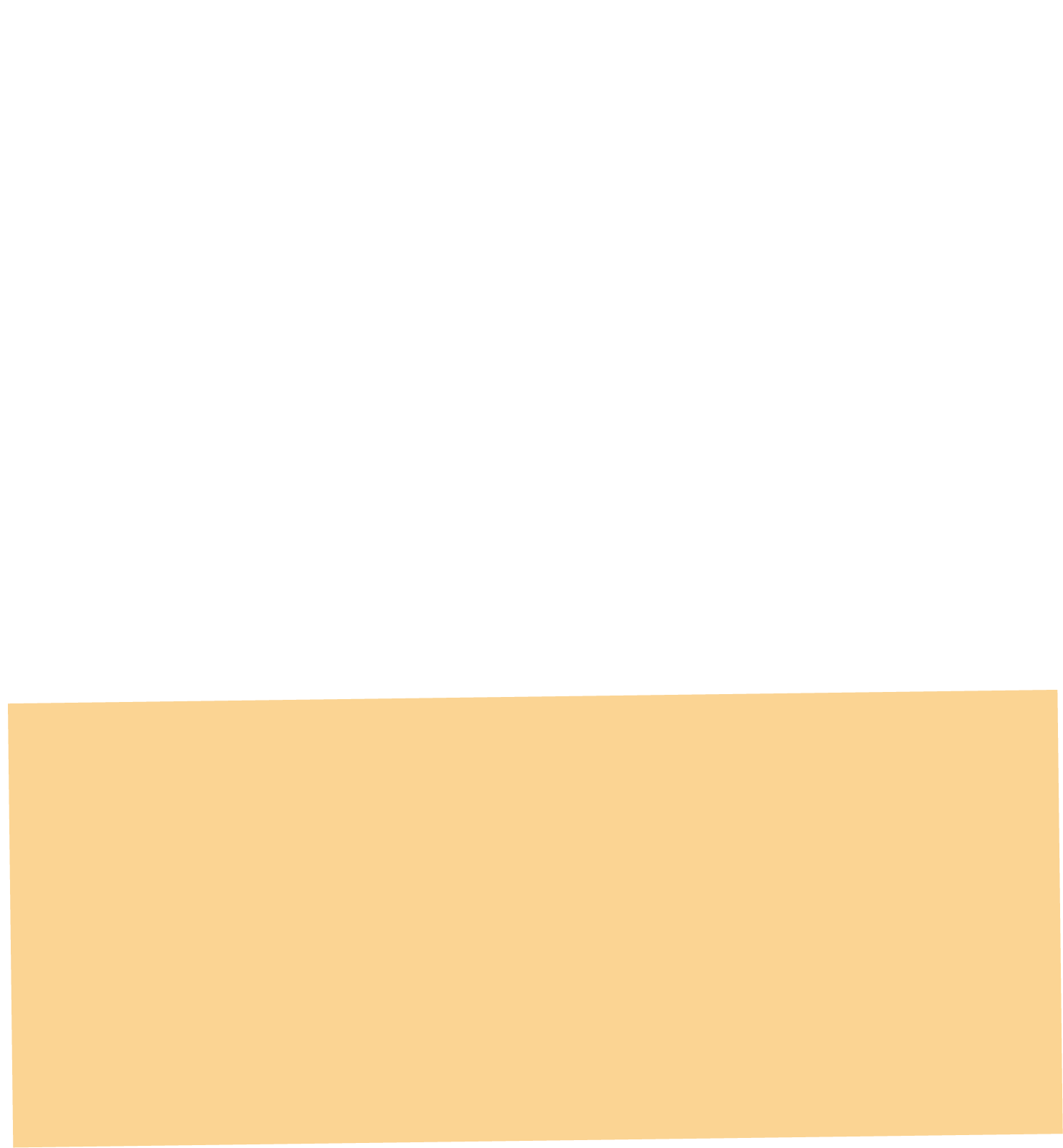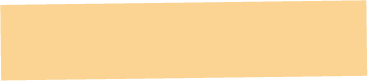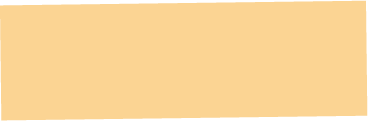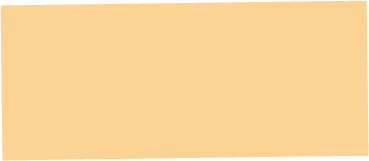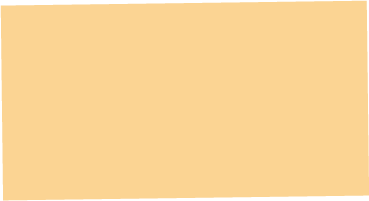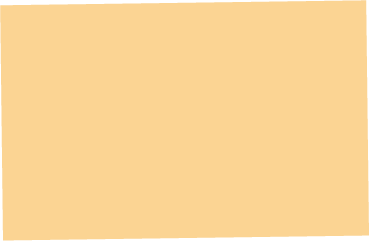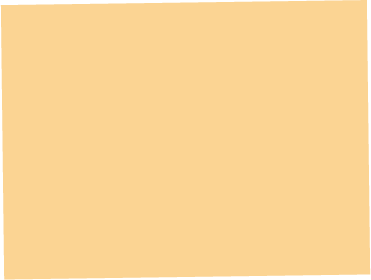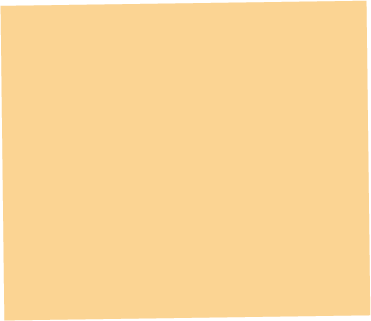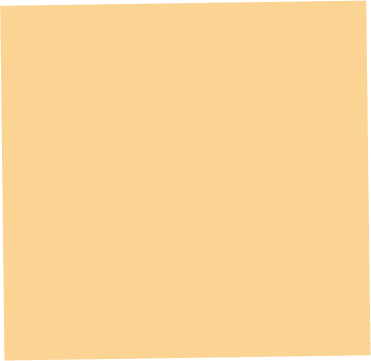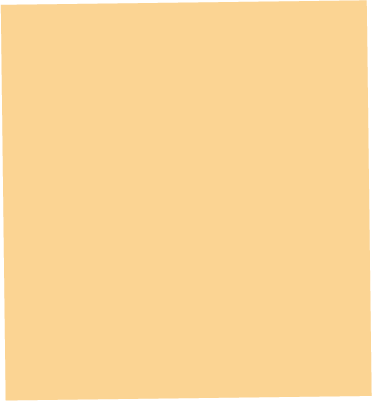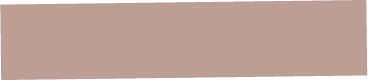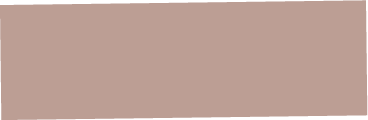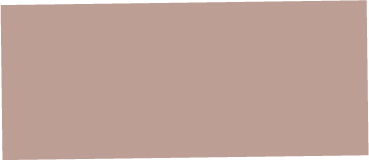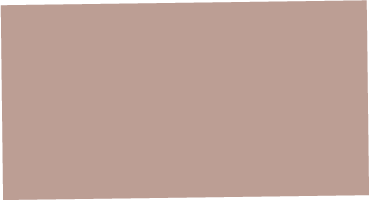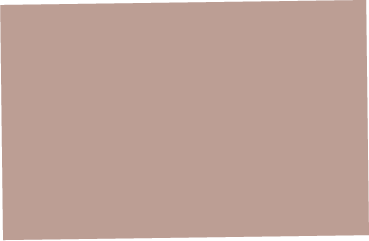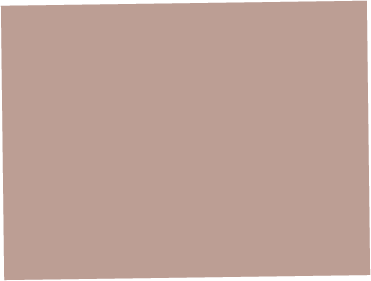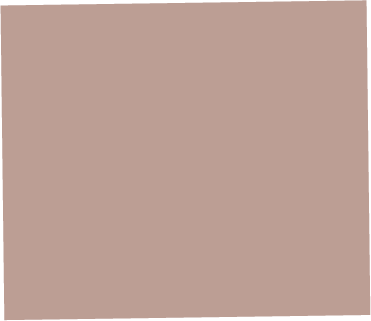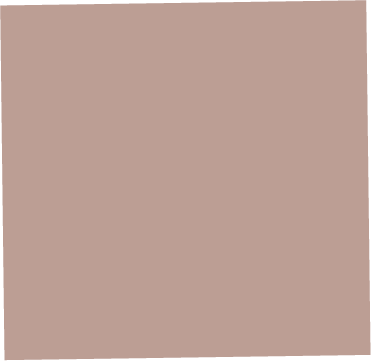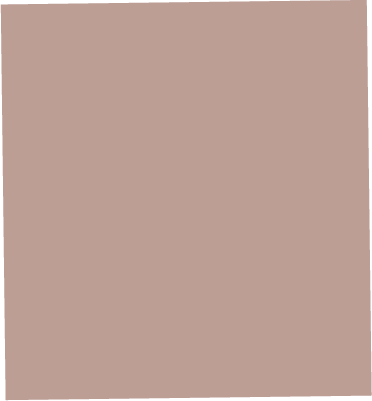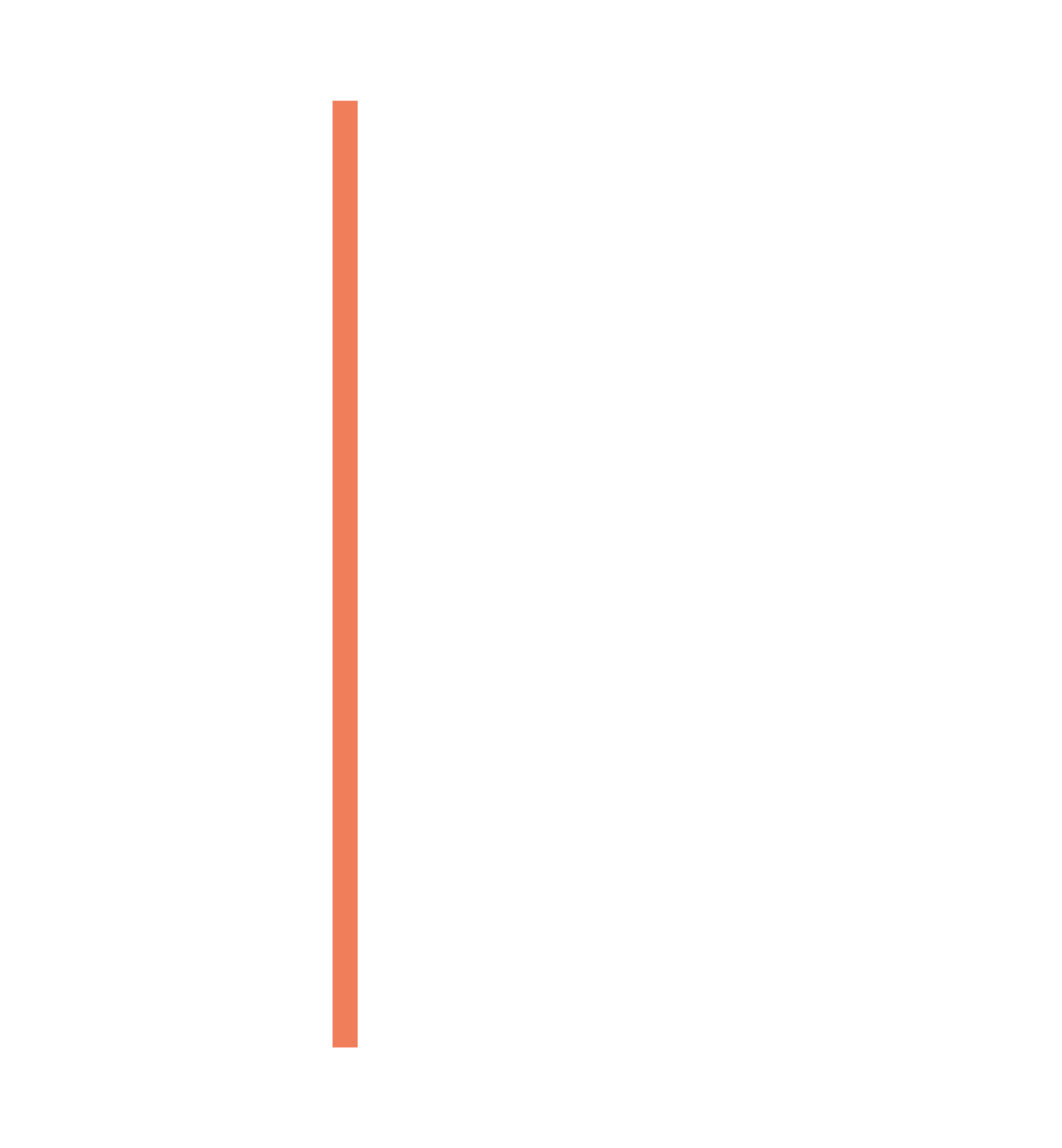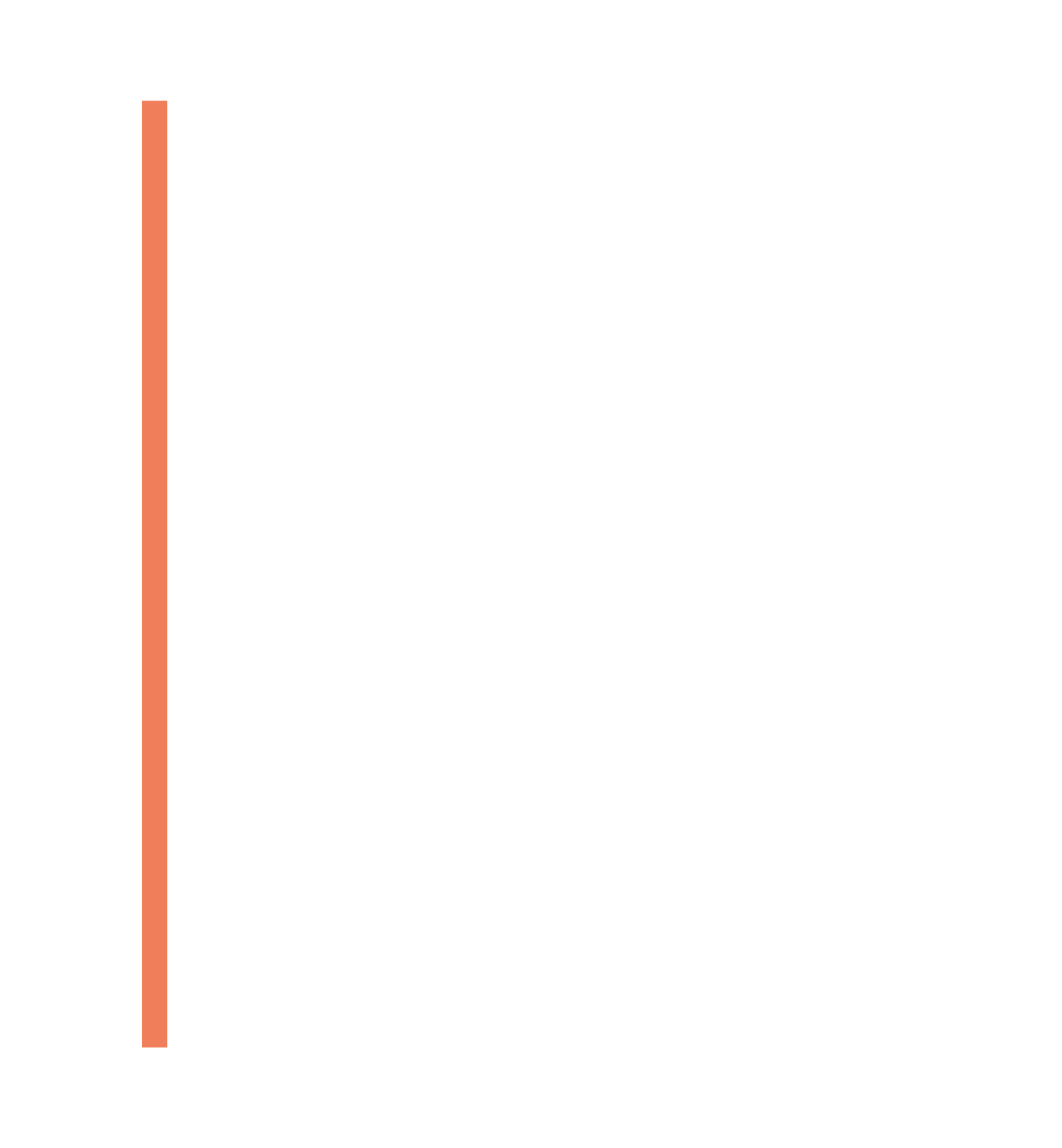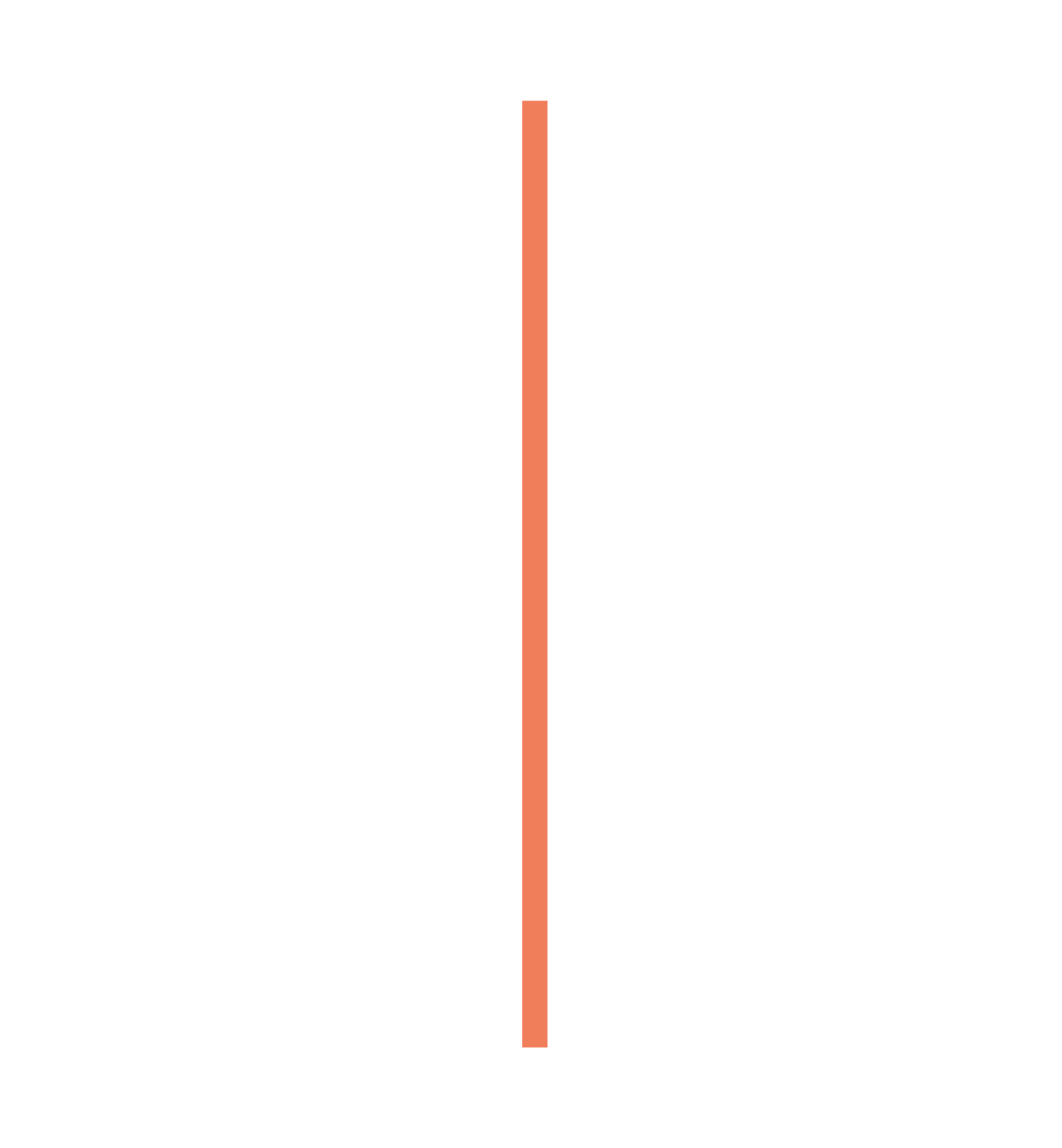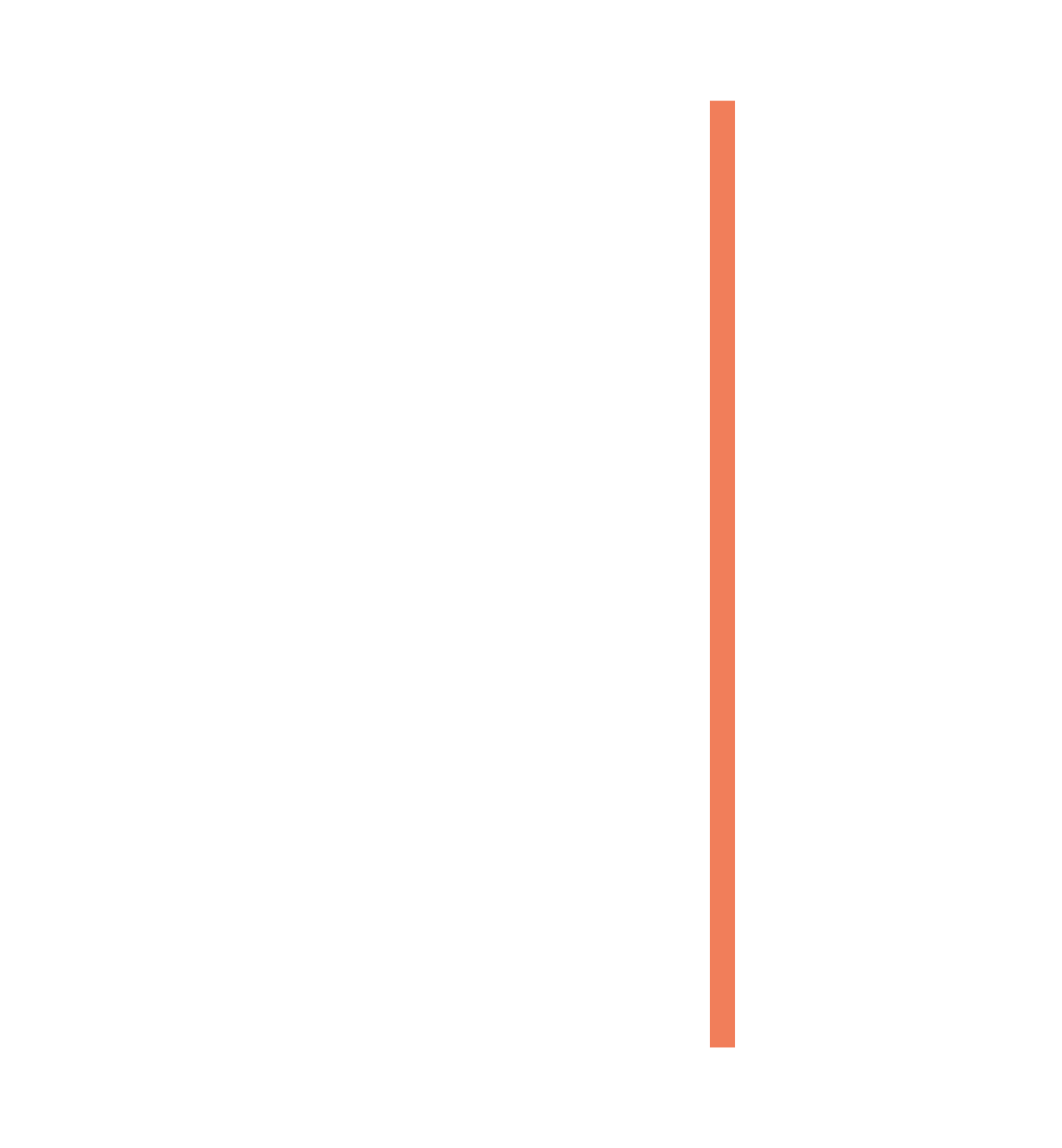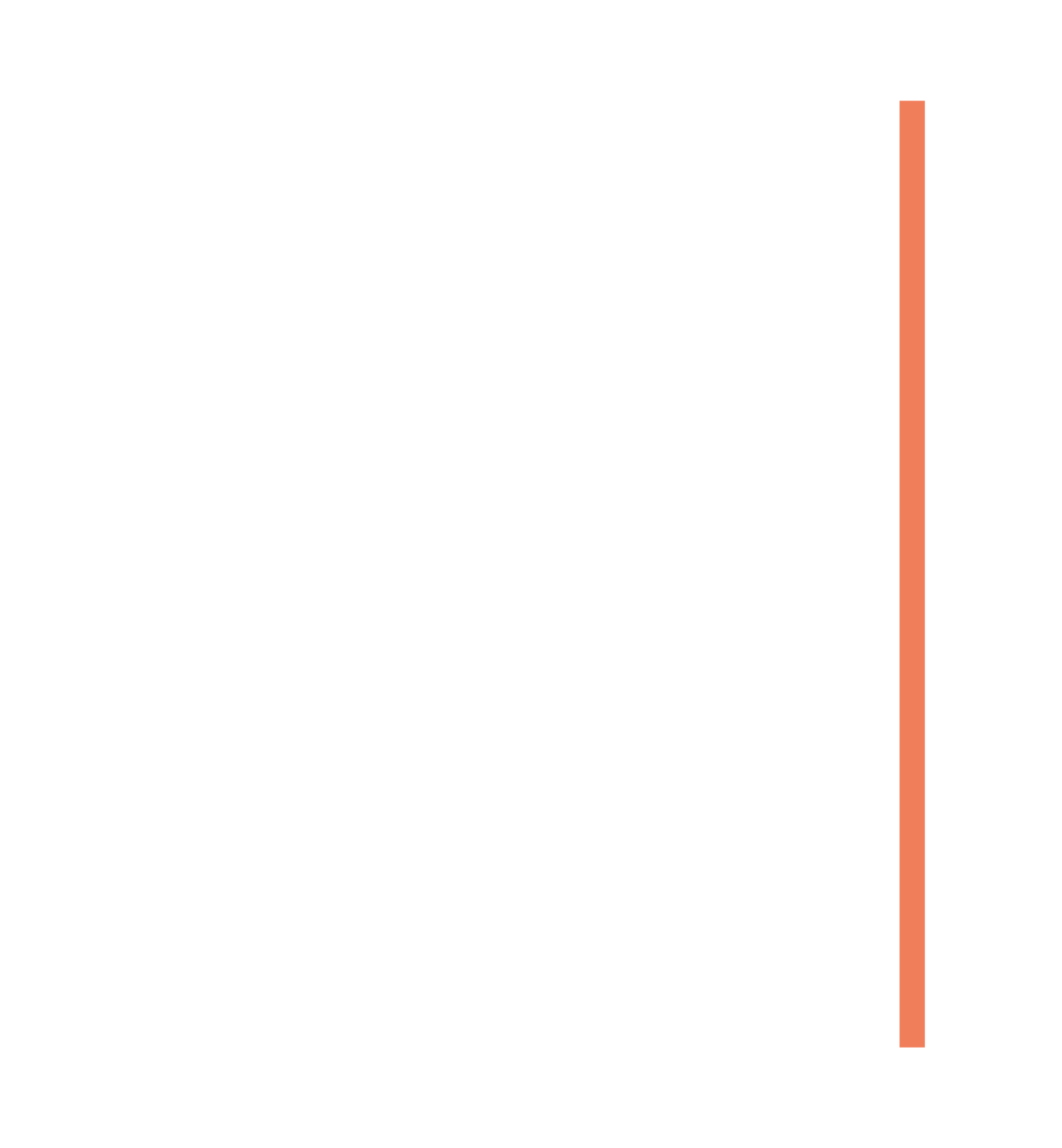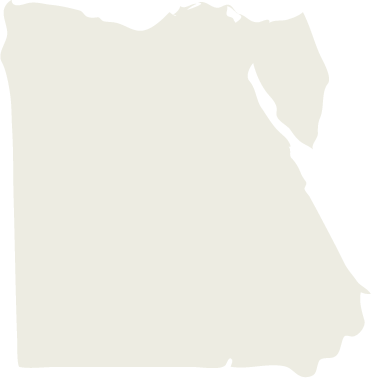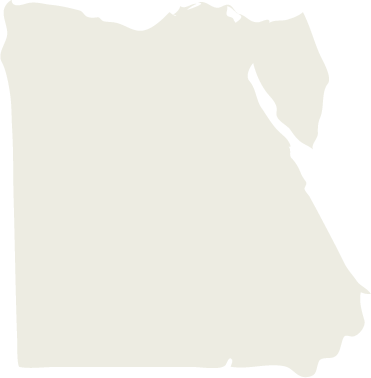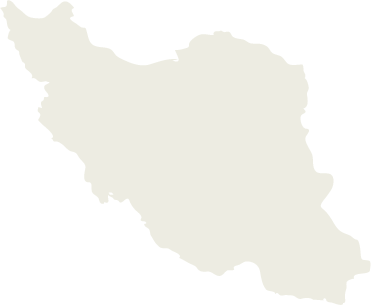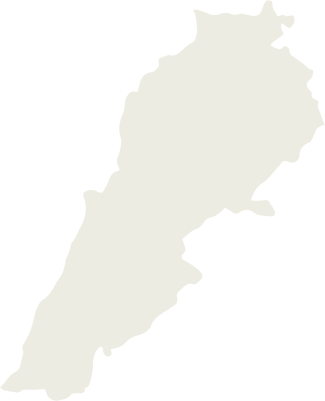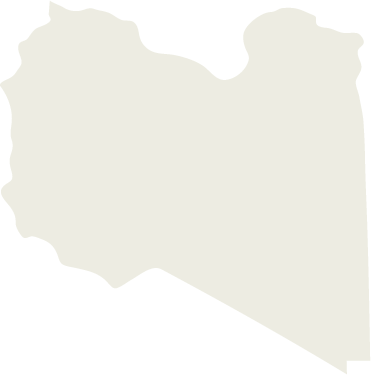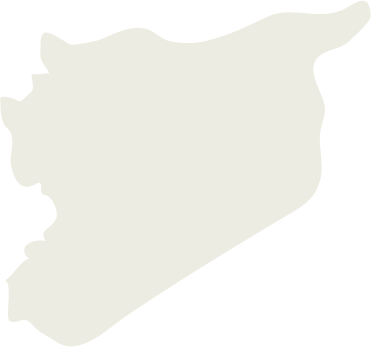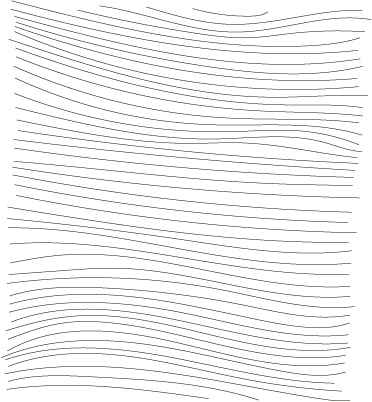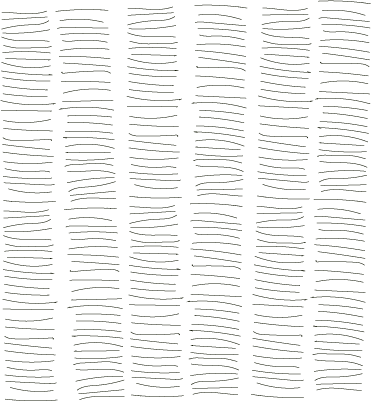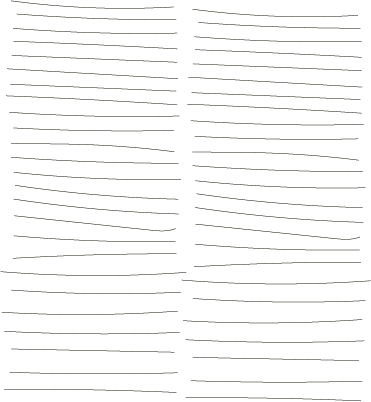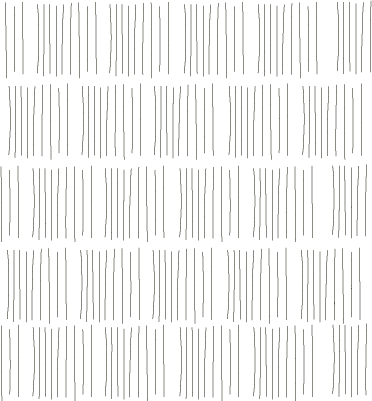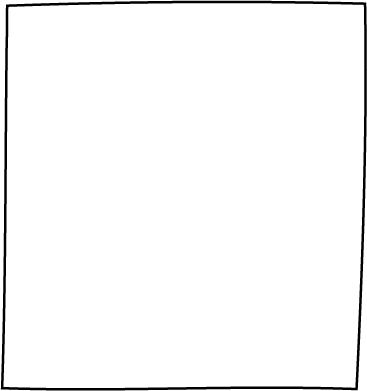Jeanette Sagues nasce al Cairo nel 1948, figlia di Maurice e Victoire Harouche, una coppia con radici familiari che si estendono lungo tutta la sponda sud-orientale del Mar Mediterraneo. La madre di Victoire proveniva dalla Siria, mentre il padre, nato in Palestina e naturalizzato francese, si era trasferito ad Alessandria d’Egitto, dove divenne direttore del lycée français. Il nonno paterno di Jeanette, nato in Turchia, si era stabilito al Cairo con i suoi cinque figli dopo la morte della moglie, originaria di Salonicco ma conosciuta in Siria. A vent’anni, Victoire, spinta dal desiderio di emancipazione, si trasferisce in Sudan per lavorare come segretaria in una società di commercio. Dopo qualche anno, viene trasferita di nuovo al Cairo, nello stesso ufficio dove lavora Maurice, l’uomo che diventerà suo marito. Si sposano nel 1943 e dalla loro unione nascono Jacques, Jeannette e Francine.
La famiglia Sagues inizia la propria vita nel quartiere popolare di Bab El Louk, per poi trasferirsi in una casa più grande nell’area di Zamalek, nella parte nord dell’isola di Gezira sul Nilo. In casa, i genitori parlano tra loro in ladino, mentre il francese è la lingua di tutta la famiglia. Victoire è particolarmente attenta a preservare l’identità ebraica della famiglia. Pur non essendo religiosi, rispettavano le festività ebraiche, mantenendo vive le tradizioni. Allo stesso tempo, Victoire incoraggia i figli a mantenere viva anche l’identità francese, parlando la lingua e studiando nelle scuole francesi. Nonostante il forte legame con la cultura francese e la frequentazione di circoli europei, l’identità culturale della famiglia Sagues si arricchisce ulteriormente nel contesto domestico. A casa, infatti, si parla anche arabo con i domestici, e la madre prepara piatti tipici orientali come molokhia, sambusek e menena.
Jeanette ricorda con affetto le gite domenicali alle Piramidi e le escursioni con la famiglia al “Barrage”, la storica diga sul Nilo. L’estate, invece, portava con sé sentimenti contrastanti. La famiglia partiva a bordo della nave Esperia per raggiungere l’Europa, dove i genitori andavano a trovare amici e parenti, mentre i figli trascorrevano le vacanze in Svizzera e Francia nei kinderheim, di cui Jeanette conserva ricordi meno entusiasti.
Nel 1956, alla fine di una di queste vacanze che duravano generalmente un paio di mesi, Victoire si trovava a Ravenna con i suoi figli, ospite della sorella. Mentre è in Italia riceve un telegramma dal marito, che la informava delle pericolose tensioni scatenate dalla crisi del Canale di Suez e la esortava a rimanere in Europa per sicurezza. Victoire, al contrario, decide di ritornare dal marito e si imbarca con i figli per l’Egitto. Al loro rientro, la guerra era scoppiata in tutta la sua violenza. Il padre, Maurice, viene arrestato e messo in prigione per una settimana, mentre alla madre viene notificato un mandato di espulsione. Jeanette conserva viva la memoria dei bombardamenti notturni: ogni sera le luci dovevano rimanere spente, e i vetri delle finestre venivano coperti con carta blu per evitare che filtrasse qualsiasi bagliore. Quando finalmente il padre viene rilasciato, la famiglia si trova costretta a lasciare il paese. Non sapendo dove andare, decidono di recarsi a Parigi, dove viveva un fratello della madre. Così, in una mattina di frenesia e tensione, la famiglia esce di casa per l’ultima volta, senza mai più farvi ritorno.
Il 28 dicembre del 1956, la famiglia Sagues atterra a Parigi. Nei primi mesi furono ospitati dagli zii di Jeanette, che pochi giorni dopo l’arrivo, viene catapultata in una nuova realtà, iniziando subito a frequentare la scuola. Sebbene parlasse già il francese, il cambiamento è traumatico. Questa sensazione si ripete nel 1958, quando la famiglia si trasferisce a Milano, dove il padre aveva trovato un nuovo lavoro in Italia. Cambiare paese, casa, lingua e scuola rappresenta una nuova sfida per Jeanette.

C’è questo capitolo che tengo nel mio cuore…
Trascrizione
Jeanette Sagues:
Qui ho dieci anni quando sono in Italia, stufa marcia perché un po’, insomma…non ne potevo più di tutti questi cambiamenti: i primi dieci anni (di vita) già tre Paesi diversi. Mi iscrivono [a scuola] perché devo fare la quinta elementare, vado a fare la quinta elementare in una scuola che era totalmente dalla parte opposta di casa mia, in Piazzale Brescia.
Intervistatrice:
Dove abitava lei all’epoca?
Jeanette Sagues:
Viale Argonne, sempre lì, [quartiere] Città studi. Mia madre mi ha accompagnato [a scuola] la prima volta, mi ha accompagnato la seconda volta e poi mi ha detto “adesso cara ci vai da sola perchè non posso scendere alla mattina così presto”. [Io avevo] dieci anni, senza sapere una parola. Quindi, c’è questo capitolo che tengo nel mio cuore: prendevo questo tram 38 dal capolinea, salivo sul tram, e c’era sempre lo stesso tramviere. C’era il bigliettaio ancora all’epoca, a cui pagavo 30 lire. Avevo le mie monetine da 10 lire che mi dava la mamma, prendevo il mio biglietto e io ero terrorizzata perchè dovevo fare 40 minuti di tram senza sapere l’italiano, dovendo stare attenta a dove scendere… e allora si era intenerito questo tramviere, che mi ricordo che una volta mi ha detto “Vieni qui bambina [in dialetto milanese]”. Mi prendeva la cartella, perchè non c’erano gli zaini, avevo la mia cartella di cuoio, me la metteva [a terra], mi diceva di aggrapparmi alla maniglia e facevo tutto il viaggio lì con lui che mi insegnava l’italiano.
Intervistatrice:
Il guidatore o il bigliettaio?
Jeanette Sagues:
Il guidatore, perché io salivo sul tram e andavo dal guidatore e dicevo le parole che avevo imparato “Per favore, fai scendere bambina Piazza Brescia, grazie”. Queste erano le parole che mi avevano insegnato. E una e due [volte], ad un certo punto il tramviere mi dice “Vieni qua” e io [gli ho detto] “io sono francesa, non capire italiano”. Allora questo qui si è affezionato e piano piano mi parlava in italiano, tant’è che la prima frase che avevo fatto era “è vietato parlare con il guidatore che non deve essere distratto dalla manovra”. Allora gli ho chiesto “perchè mi parli, non mi devi parlare perchè tu devi guidare” e lui mi ha detto “no, per te, io posso parlare con te”. Poi mi faceva scendere in Piazzale Brescia e io dovevo fare tutta la via Domenichino, però non c’erano i semafori. Lui mi diceva di aspettare facendo cosi con la mano, poi faceva “cling” col piede e lì sapevo che potevo attraversare. Finché non sentivo “cling” io non passavo.
Mentre la madre continua a frequentare le amiche del Cairo ritrovate a Milano, Jeanette fa amicizia con i suoi compagni di scuola e con alcuni coetanei della comunità ebraica milanese. A 17 anni, partecipa a un viaggio in Israele organizzato dalla Federazione Giovani Ebrei Italiani, ma ne rimane delusa, percependolo come un “viaggio di propaganda”. Poco dopo, Jeanette si trova coinvolta nei movimenti studenteschi del Sessantotto. Questa esperienza la spinge a ripensare il suo rapporto con l’ebraismo e la propria identità.

io cercavo un’identità all’interno di queste lotte
Trascrizione
Jeanette Sagues:
Arriva il Sessantotto e io mi appassiono. Mi appassiono perchè incontro, prima con questo Stefano che faceva medicina, l’occupazione e mi ricordava molto un po’ l’ambiente ebraico, cioè “siamo simili, siamo noi, dobbiamo difenderci, qualunque cazzata tu dici, ma siamo noi”…per cui per me era molto importante. Poi conosco un altro ragazzo che poi è diventato mio marito, il primo marito, che faceva architettura, e lascio Stefano, la storia finisce e mi metto con quest’altro. E’ pieno Sessantotto, per cui io partecipo, ho vent’anni tondi, con tanta…cioè, io cercavo un’identità all’interno di queste lotte.
Dopo aver iniziato a lavorare come segretaria grazie alla conoscenza delle lingue e ai suoi studi di interpretariato, trova successivamente impiego come insegnante di francese in una scuola di formazione professionale, dove continua a lavorare fino alla pensione. E’ da adulta, anche attraverso il rapporto con le figlie e con i nipoti, che Jeanette si riconcilia con la sua identità ebraica. Inoltre, nel 2008, ha l’occasione di tornare in Egitto sulle tracce di quella che è stata la sua vita al Cairo, un momento importante in cui si trova a fare i conti con il suo passato.

è come se io fossi ritornata da una mamma che mi aveva lasciato da piccola
Trascrizione
Jeanette Sagues:
Beh è stata una cosa molto commovente, molto emozionante perchè – se posso fare una sintesi – sono ritornata, è come se io fossi ritornata da una mamma che mi aveva lasciato da piccola e che quando io mi ripresento da grande lei non mi riconosce, ma io sì!